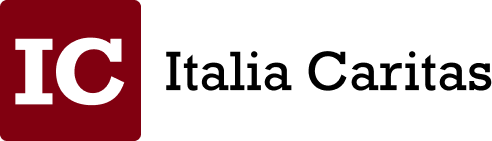Chiesa segno

Siamo seduti su di un muretto, ancora umido di pioggia, nel parco dell’Urbaniana. Vescovi da tutto il mondo, che partecipano alla settimana di formazione, raggiungono l’aula dove si terranno le prossime lezioni. La piccola croce di legno che padre Davide Carraro porta al collo (un dono di amici) rappresenta bene la minuscola comunità – fragile e tenace – per la quale è stato ordinato vescovo lo scorso 26 gennaio. È un missionario del PIME, trevigiano. La sua diocesi, Orano, si trova in Algeria e conta qualche centinaio di fedeli.
«Rispetto a una chiesa italiana – dice – la nostra è un po’ originale. Territorialmente un terzo dell’Italia, conta circa dieci milioni di abitanti. I cristiani locali sono una cinquantina. Gli altri sono migranti. Cristiani di passaggio, come tutti noi, io per primo, siamo di passaggio». Originale «nel senso che il nostro ministero, la nostra testimonianza cristiana si rivolge in modo particolare a una popolazione che è musulmana». La cifra di questa testimonianza mons. Carraro l’ha riassunta nel suo motto episcopale – «Dio è amore» – e nella lettera scritta per la ripresa delle attività pastorali, dopo una prima visita delle sue sei parrocchie. «Battezzati e non battezzati, cristiani, musulmani o persone in ricerca, siamo chiamati a lavorare per il bene di tutti e di ciascuno in nome della nostra comune umanità». Sul suo stemma un’ape simboleggia laboriosità, socialità e dolcezza.
Padre Carraro è arrivato in Algeria nel 2006 a seguito della sua ordinazione a Treviso. Dopo due anni di servizio nella diocesi di Laghouat è partito per l’Egitto allo scopo di imparare bene l’arabo. Problemi di visto gli hanno impedito di rientrare in Algeria (nel frattempo è stato missionario in Costa d’Avorio) fino al 2017. Ad Algeri dal 2019, nel 2022 l’arcivescovo della capitale, Jean-Paul Vesco, lo ha voluto suo vicario generale. Di lui ha detto, annunciandone la nomina avvenuta lo scorso ottobre: «Davide è una bellissima figura di umanità e gentilezza, una figura che mancherà all’arcidiocesi di Algeri e che mancherà molto a me a livello personale. Ma rendo grazie per questa nomina che fa bene alla diocesi di Orano, alla nostra Chiesa e allo stesso Davide che riceve la responsabilità di una diocesi bella e affascinante».
Proprio la bellezza è al centro della vita di mons. Carraro. «Sei una bella persona», dice a quelli che incontra. “Vous êtes une belle personne” è il titolo della sua lettera (vedi sotto). Rivolta a una comunità che è il luogo del dono e del perdono.
Una diocesi per poche centinaia di cristiani. Una sfida, una chance?
«Grosso modo in tutto saremo 300, quelli conosciuti, di cui una parte sono migranti che vorrebbero raggiungere l’Europa. Altri sono studenti dell’Africa subsahariana e infine una cinquantina tra preti e religiosi e religiose, che lavorano nella diocesi. Quasi tutti siamo di passaggio, perché i migranti sono di passaggio, gli studenti sono di passaggio, così come spesso i religiosi o i pochi lavoratori stranieri. Siamo anche una chiesa ecumenica perché tra i migranti, e parte degli studenti, molti sono evangelici. Frequentano le nostre chiese come luoghi della fede che riconoscono accoglienti anche per loro. I migranti cristiani possiamo incontrarli anche nelle prigioni».

Lei è un vescovo missionario. Una parola che ha cambiato significato nel corso dei secoli. Che cosa significa oggi?
«Essere vescovo missionario credo voglia dire semplicemente cercare di annunciare l’amore di Dio a tutti, in particolare lì dove si è mandati».
Ci sta dicendo che non occorre essere vescovo per essere missionario.
«Per essere missionario basta avere questo desiderio nel cuore di voler annunciare l’amore di Dio a tutti».
Anche se lei operasse in Italia, avrebbe dunque la stessa missione.
«Certo, vale per un vescovo in Italia, ma anche per un qualsiasi cristiano italiano. Credo che dietro la parola missionario ci sia poi l’idea di andare in una terra diversa dalla propria. Di mettersi in cammino».
Che cosa significa essere una piccolissima minoranza in una grande grande maggioranza di fede islamica?
«Significa essere se stessi e allo stesso tempo accettare di essere in minoranza, quindi di non far parte della parte forte o predominante, cosa che comporta una certa umiltà, semplicità, ascolto. Credo che comporti anche un saper imparare dall’altro. Io mi sento arricchito da molte esperienze che vivo con i fratelli e le sorelle musulmane. La loro carità, il loro modo di amarsi interpella il mio cuore… Alcune volte mi spinge anche ad essere un cristiano migliore. Mi danno l’esempio».
Ha avuto esperienza anche di episodi di conflitto e intolleranza tra cristiani e musulmani?
«Certo, ci sono. In tutte le famiglie e in tutti i luoghi ci possano essere dei conflitti. Credo faccia parte della vita. Alcune volte siamo noi a non capire, a criticare, alcune volte leggiamo, anzi leggo la realtà con le mie categorie, senza fare attenzione alle categorie dell’altro, alla storia dell’altro… Quando emergono delle difficoltà però si superano con il dialogo e con la perseveranza».

Una volta si misurava l’efficacia dell’azione missionaria dal numero dei battesimi o delle conversioni. Oggi come si misura l’efficacia relazione missionaria?
«Non so se bisogna davvero misurarla in cifre. Io credo che la missione la faccia Cristo, certamente attraverso di noi, ma è Cristo a farla. E io credo che nella misura in cui siamo testimoni fedeli e autentici, in quel momento lì siamo efficaci. Il resto non dipende da noi».
Poche settimane fa papa Francesco, parlando ai giovani a Singapore, diceva che «tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio». È questo l’atteggiamento della chiesa presente nei Paesi a maggioranza islamica secondo la sua esperienza?
«Sì, perché, lo ripeto, l’esperienza religiosa dell’altro ci arricchisce e ci avvicina a Dio. Ne parlo da straniero in Algeria: io mi sento arricchito. Sono arricchito dall’esempio di tanti amici e amiche musulmane. Per cui sì, sono convinto di questa realtà. Credo che quando si parla dell’universalità della chiesa non si intenda solo l’universalità sul piano delle nazionalità, delle culture diverse, ma anche delle religioni diverse che si ritrovano sostenute da pilastri, valori comuni».
Alla sua ordinazione erano presenti anche sorelle e fratelli musulmani. Per curiosità o per una partecipazione dovuta al fatto che la popolazione sente la piccola comunità cristiana come qualcosa che le appartiene?
«Se la chiesa vuole avere degli amici in Algeria, li ha solo se sa instaurare delle relazioni con la popolazione che è in gran parte musulmana. Per questo molti erano presenti soprattutto per amicizia, per un legame con la chiesa e con la chiesa di Orano. È una situazione edificante: almeno la metà non erano cristiani, tra quelli che hanno partecipato alla celebrazione, e chi ha partecipato, al di là di alcune autorità che erano presenti per dovere di rappresentanza, era lì perché esistono delle buone relazioni».
Il suo motto episcopale è “Dio è amore”. È la sintesi del messaggio cristiano. È anche ciò che dà contenuto all’azione della Caritas (“Deus caritas est”) che porta nel nome la sua missione: animare le comunità alla carità, ricordare ai cristiani e alle comunità che l’amore dà senso a tutte le cose.
«Ho scelto questo motto anzitutto perché lo sento mio. Poi perché ho visto che nelle chiese in cui siamo presenti, nelle chiese di Orano e in molte delle nostre comunità, c’è questa scritta: Dio è amore. È una cosa quindi che mi precede, qualcosa che chi c’era prima di me ha cercato di vivere. La Caritas in Algeria purtroppo è stata sciolta come organizzazione alcuni anni fa, naturalmente non per volere nostro. Ma rimane forte nel nostro Dna la spinta a cercare di amare gli altri, come dei genitori che non possono non amare i propri figli. Per questo le opere di carità rimangono e la vicinanza a chi bussa alla nostra porta perché si trova in difficoltà cerchiamo di manifestarla con cuore. Mi sono convinto che quanto più noi riusciamo a mettere al centro i poveri, quanto più riusciamo a mettere al centro della nostra vita chi bussa alla nostra porta, tanto più diventiamo una chiesa bella e siamo capiti anche da chi è diverso da noi per tradizione di fede. Sono convinto che è il povero che ci insegna. Non siamo noi a insegnare al povero, ma è il povero che ci insegna come arrivare a Cristo e come essere felici».
La chiesa in Algeria ha avuto anche dei martiri. Quanto è presente la loro testimonianza nella pastorale e nella vita?

«Pierre Claverie e i suoi 18 compagni sono molto presenti nelle nostre chiese. Sono martiri della presenza, martiri della fedeltà all’amore di Dio. Martiri perché hanno scelto di rimanere. Sì, sono presenti. Io abito nel luogo in cui Pierre Claverie, che dona il nome alla causa di questi martiri – Pierre Claverie e i suoi 18 compagni e compagne – è stato ucciso. Abito in quel luogo. Lui è sepolto nella cattedrale. Tra due anni celebreremo i trent’anni del suo martirio. Sono presenti, sono delle figure per noi importanti. Al di là di Pierre Claverie e Christian de Chergé, gli altri martiri non hanno scritto molto. Ci mostrano che la santità è per tutti, perché erano delle persone normali che hanno vissuto con normalità la loro vita, cercando di dare ad essa un senso amando gli altri».

Da quello che racconta esce spesso la parola “presenza”. È un elemento importante della vostra pastorale?
«Certo. Quando non si è numerosi è importante essere presenti. Esserci. Credo che in tutte le relazioni la presenza faccia la differenza. Una relazione umana si rafforza nella misura in cui si è presenti».
Quanto si manifesta in Algeria il fenomeno della povertà?
«L’Algeria è un Paese emergente. È un Paese che fondamentalmente sta bene. Perciò la povertà come può immaginarsela un italiano pensando all’Africa in Algeria non c’è. Ci sono delle buone infrastrutture. Questo ci interroga anche sul nostro modo di essere chiesa, sulle nostre attività che si devono adeguare a un Paese emergente, un Paese giovane. Credo che in questo contesto, mettere al centro il povero – che comunque è presente – ci aiuta e ci aiuterà ad essere una chiesa attuale per l’Algeria di oggi».
Chi è soprattutto il povero in Algeria?
«Come in tutte le società, anche in Italia, i poveri ci sono, ma alcune volte non si vedono: persone marginalizzate, ammalate, che hanno difficoltà a trovare lavoro, che non sono integrate… Siamo chiamati ad avere attenzione per queste persone, che non sono solo migranti, ma possono essere anche algerini, persone abbandonate, persone che sono, appunto, un po’ invisibili nella società».
In Italia il fenomeno della solitudine degli anziani, ma non solo, è molto presente. Com’è la situazione in Algeria?
«Credo che in Algeria ci sia un approccio un po’ diverso. Ci sono certamente delle persone sole… La nostra chiesa ha anche un centro gestito dalle Piccole Sorelle dei Poveri in cui abitano 57 persone anziane che stanno lì fino alla fine della loro vita. Sono anziani che non hanno altra possibilità per essere ospitati e stanno con noi per continuare ad avere una vita degna. Però credo che la società algerina di oggi sia più attenta alla persona anziana che non la società occidentale e che gli anziani generalmente siano messi più al centro della vita di una famiglia rispetto a ciò che avviene in una società occidentale».
Cosa possiamo fare noi per essere vicini alla chiesa di Orano e all’Algeria?
«Mi vengono in mente due elementi che abbiamo in comune. Uno sono i migranti. Avere dunque attenzione per questa fascia di popolazione. Un altro aspetto che ci lega riguarda in particolare gli immigrati di origine musulmana, magrebina, che abitano nelle nostre zone. Cercare di accoglierli, di essere attenti alla diversità dell’altro, rispettosi e non paurosi. Poi forse un altro elemento importante che abbiamo in comune è quello di impegnarci attivamente per la nostra chiesa, di sentire che la chiesa in un certo qual modo è la nostra famiglia. Dico questo perché in Algeria siamo in pochi e cerchiamo di fare famiglia, di sentirci famiglia tra di noi e di coltivare assieme la fede».

Dalla lettera per l’inizio dell’anno pastorale
I POVERI
Ci è stato proposto un nuovo paradigma nell’incontrare le persone. Non segue più la dinamica insegnante-allievo, donatore-beneficiario, ricco-povero. Ci invita a entrare senza complessi nella dinamica di una fraternità feconda, nutrita e rafforzata dalla collaborazione e dall’aiuto reciproco.
Se vogliamo che Dio parli di più alla nostra vita e alla nostra Chiesa, dobbiamo mettere al centro i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono. In realtà non mi piace la parola “povero” perché la trovo stigmatizzante. Sono i nostri maestri di vita.
I LUOGHI DELLA CARITÀ
Sono molte le iniziative per aiutare i nostri fratelli e sorelle in difficoltà: aiuto, accompagnamento e ascolto. Visite ai malati anziani in difficoltà presso “Ma Maison”. Sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie, assistenza alle persone a mobilità ridotta. persone a mobilità ridotta. Aiuto alle persone in difficoltà psicologica e problemi relazionali…
Tutto questo ci dimostra che la nostra vocazione primaria è quella di vivere insieme come fratelli e sorelle. Ci insegna che, quando uno di noi è caduto a terra, è urgente rialzarlo. Ma mi sembra anche necessario riflettere con lui sulle soluzioni e le iniziative da mettere in atto per far sì che nessuno cada.
UNA CHIESA TOCCATA DALL’ISLAM
La nostra Chiesa di Orano è stata caratterizzata dall’Islam fin dall’VIII secolo. In questo contesto, noi, minoranza cristiana battezzata, siamo continuamente invitati a essere un segno di Cristo, a essere come il lievito nella pasta. Siamo una piccola Chiesa chiamata a essere un segno.

Nel nostro Paese, la vita della nostra comunità cristiana acquisisce il suo pieno significato e il suo pieno valore solo quando vive in armonia, mano nella mano, con le nostre sorelle e i nostri fratelli musulmani.
Non possiamo essere veramente Chiesa senza una vera e profonda amicizia con loro. E credo che un’alleanza tra credenti sia possibile a condizione che ognuno di noi si impegni con fede e determinazione. La nostra vita quotidiana lo testimonia ampiamente.
Aggiornato il 22/09/24 alle ore 15:32