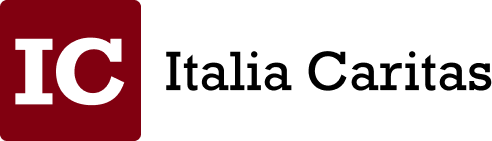Le banane che affamano La Blanca

Temperature torride e aria satura di umidità. È il clima che si percepisce scendendo dall’altipiano del dipartimento di San Marcos a La Blanca, piccolo municipio di circa 37 mila abitanti situato sulla costa occidentale del Guatemala, appena sotto la frontiera con il Messico.
Il caldo e l’abbondanza d’acqua di questa zona la rendono il luogo perfetto per la crescita del banano. Queste risorse notevoli sono purtroppo sfruttate più dalle grosse imprese agroindustriali che dalla popolazione locale. Infatti, dalla metà del XX secolo il possesso e l’uso di queste terre si è accentrato nelle mani di due principali aziende produttrici di banane destinate all’esportazione: Banasa e Grupo Hame.
Deforestazione per avere più suolo coltivabile,
piogge che causano inondazioni, diritto all’acqua
negato: il land grabbing penalizza i piccoli produttori
Questa concentrazione nelle mani di pochi di terre destinate alle monocolture si inquadra nel cosiddetto fenomeno del land grabbing (analizzato da un Dossier Caritas) e ha avuto conseguenze drammatiche sulla popolazione di La Blanca. Innanzitutto, la deforestazione per ottenere una maggiore estensione di suolo coltivabile fa sì che, in periodo di piogge, si inondino le coltivazioni dei piccoli produttori. Le due grandi imprese, infatti, si sono dotate di paratie e non subiscono danni. Inoltre, è negato alle famiglie contadine il diritto all’acqua, che viene convogliata per l’irrigazione delle monoculture attraverso il cambio del corso dei fiumi. I terreni della popolazione locale restano quindi a secco, compromettendo le raccolte annuali di colture essenziali all’autosostentamento famigliare: mais, platano, fagioli e frutta.
Come orientarsi tra le etichette?
Impossibilitati a provvedere autonomamente all’approvvigionamento di cibo, i piccoli contadini sono costretti a diventare lavoratori salariati nelle stesse monocolture di banano, spesso in condizioni lavorative precarie e irregolari, o a migrare nella speranza di provvedere ai bisogni della famiglia con rimesse di denaro dall’estero.
Infine, come conseguenza annunciata di ogni coltivazione del suolo con una sola specie di pianta, c’è la drastica riduzione della biodiversità della zona. La scelta della monocultura rende necessario l’utilizzo di pesticidi chimici per combattere gli insetti infestanti, perché è stato distrutto l’equilibrio dell’ecosistema naturale. Ma i residui chimici e gli scarti di produzione e imballaggio delle banane inquinano gravemente l’acqua dei fiumi, pregiudicando la salute della popolazione locale.
Per riassumere, i cittadini de La Blanca soffrono quotidianamente le conseguenze ambientali, sociali ed economiche della presenza massiccia dei due colossi dell’esportazione bananiera, che possono contare su un ampio mercato per i propri prodotti negli Stati Uniti e in Europa.
Monocoltura delle banane: la popolazione locale
subisce, dal punto di vista sociale, economico
e ambientale, le scelte delle grandi multinazionali
Infatti, è proprio nei supermercati nostrani che arrivano queste banane. Quelle prodotte da Banasa si fregiano, oltretutto, della certificazione di “sostenibilità ambientale, sociale, lavorativa e agricola” della Rainforest Alliance, in una lucrativa operazione di lavaggio della propria immagine.
I consumatori, a cominciare da noi italiani, dovrebbero interrogarsi più a fondo sulla nostra loro responsabilità nell’influenzare la domanda di un prodotto, che lascia dietro di sé un tale elenco di disastri ambientali e sociali, ricordando che quello della costa guatemalteca è solo un caso applicabile a svariati prodotti esposti sugli scaffali delle catene dei supermercati. C’è da chiedersi, però, quali strumenti ha il consumatore per orientarsi fra le numerose etichette che dovrebbero essere garanzia di una produzione sostenibile a livello umano e ambientale, ma che in realtà riescono a eludere questa promessa.
Paradigma agroecologico
Un rapporto del 2018 della fondazione Changing Markets mostra come la proliferazione degli ultimi anni di certificazioni internazionali crei confusione nei consumatori e venga utilizzata talvolta come sistema di copertura di metodi di produzione che le organizzazioni non profit e i ricercatori non definirebbero sostenibili. Questo è possibile perché esistono diversi sistemi di certificazione che utilizzano diversi indicatori, che possono e devono essere oggetto di discussione. Ovviamente è difficile, se non impossibile, che tale analisi sia svolta dal comune consumatore, che dovrebbe districarsi in una giungla di norme applicate alle filiere produttive di prodotti provenienti dall’altra parte del globo terrestre.
m

Un suggerimento su come affrontare tale dilemma arriva da un’altra zona del dipartimento di San Marcos. Qui i contadini dell’altipiano hanno creato, con l’appoggio della Pastoral de la Tierra (ente partner di Caritas), la Redpass, una rete di piccoli produttori che adotta principi agroecologici, vendendo in un mercato contadino la frutta e verdura che producono localmente. Questo esempio virtuoso ricorda tanti numerosi mercati contadini delle nostre città e dei nostri paesi, senz’altro più piccoli e meno vistosi di un supermercato, che costituiscono reti locali resistenti alle logiche oppressive del mercato internazionale. Una possibile soluzione può trovarsi, quindi, guardando “nel proprio giardino” e scoprendovi coltivazioni stagionali su piccola scala, che accorciano la distanza fra chi produce e chi compra, aumentando le capacità del consumatore di conoscere il cibo che arriva sulla sua tavola.
Il “paradigma agroecologico”, cercando di dare al concetto di sostenibilità un significato a 360 gradi, si propone quindi come modello alternativo a quello dell’agroindustria, incentivando la produzione e il consumo locale, in una relazione uomo-ambiente realmente sostenibile per il Nord come per il Sud del mondo.
* Volontaria in servizio civile in Guatemala
Aggiornato il 05/04/22 alle ore 10:38