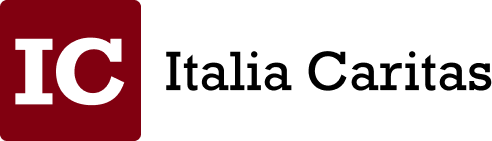«Gibuti? Ormai è la mia casa»

Un territorio arido e assolato, un terreno secco e brullo. Dall’orizzonte spira un vento caldo, sembra il fuoco dell’inferno. È il 2015 quando Sara Ben Rached, una ragazza italiana, mette piede per la prima volta nelle terre del Corno d’Africa. Porta con lei una valigia piena di sogni. Tra questi vi è il desiderio di mettersi a servizio in una realtà diversa dalla sua. I suoi sogni la conducono in Gibuti, come Casco Bianco per Caritas Italiana. Lì Sara si fermerà anche dopo il termine previsto dal progetto.
Molteplici sono gli incontri che l’hanno segnata. Tanti i volti che Sara non può dimenticare. Tra di loro ci sono quelli dei ragazzi di strada. Gli occhi, i sorrisi di quei bambini soli, costretti a dormire dove capita, senza un tetto sopra la testa. Obbligati a diventare grandi troppo presto, tra prostituzione, violenza e droga. L’estrema povertà li ha spogliati anche dell’unica cosa che resta: la loro infanzia. Sara, insieme a tante altre persone, cerca di rimettere insieme i pezzi, i frammenti di quelle giovani vite distrutte.
Da allora Sara non ha mai lasciato i suoi bambini. Oggi Gibuti è diventata la sua casa e da quelle terre porta avanti con coraggio e determinazione la nuova missione che le è stata affidata: la direzione di Caritas Somalia. Tante sono le sfide e gli scenari complessi con i quali si deve misurare ogni giorno. Molti i passi percorsi in questo cammino, iniziato otto anni fa, quando, per la prima volta, il piede di Sara accarezzò le terre africane. Lo racconta in questa intervista.
Da Casco Bianco nel 2015 a direttrice di Caritas Somalia oggi: Sara Ben Rached, ci racconti un po’ la tua storia?
«Sono arrivata a Gibuti dopo aver finito il mio anno di Erasmus in Marocco. Sentivo il desiderio di restare ancora all’estero. Ho trovato questa possibilità attraverso il bando per il Servizio civile all’estero e ho deciso di fare domanda a Gibuti. La mia è stata una scelta non troppo ponderata: ero indecisa, infatti, tra Gibuti e il Burundi. Ho pensato che in Gibuti la situazione fosse un po’ più difficile e complessa e così ho deciso di fare domanda per il Burundi. Alla fine non era proprio come avevo immaginato… Il progetto in Burundi venne chiuso dopo una settimana a causa dei disordini all’interno del Paese. Una volta arrivata in Gibuti, la situazione è diventata complicata non tanto per le guerre e i disordini, ma… per il clima terribilmente caldo. Ho scelto di diventare Casco Bianco dopo aver maturato nove anni di servizio nella Croce Rossa, dove avevo avuto occasione di relazionarmi con persone senza fissa dimora e con minori stranieri non accompagnati. Ho sentito l’esigenza di andare oltre il contesto locale, di fare qualcosa di diverso. Ho deciso così di impegnarmi verso il prossimo anche in un contesto differente dal mio».
«Ho scelto di diventare Casco Bianco dopo aver maturato nove anni di servizio nella Croce Rossa, dove avevo avuto occasione di relazionarmi con persone senza fissa dimora e con minori stranieri non accompagnati»
Ricordi le prime sensazioni e le prime immagini appena arrivata in Gibuti?
«La prima immagine, quando sono scesa dall’aereo – era il 27 settembre 2015 –, è stata quella di un paesaggio infernale. Sono stata accolta da una ventata d’aria calda e umida che mi ha tolto letteralmente il fiato, travolgendomi e regalandomi una sensazione di soffocamento che si rinnova puntualmente ogni qualvolta scendo dall’aereo di ritorno dall’Europa. Quel giorno venne a prenderci all’aeroporto (io ero con una collega) un sacerdote neozelandese che in quel periodo era in missione nella Diocesi di Gibuti. Durante il tragitto, attraversando le strade principali di Gibuti, eravamo accompagnate da un fortissimo cattivo odore, acre e pungente, proveniente da svariate pozze d’acqua stagnanti e dal collettore delle acque reflue. Ricordo ancora le parole di quel sacerdote: “Ecco l’odore di Gibuti”. Direi che come primo approccio, la situazione non lasciava presagire nulla di buono».
Sara Ben Rached, al termine del servizio civile sei rimasta in terra africana. Che cosa ti ha spinto ad abbracciare questa scelta?
«Sono rimasta qui per i bambini. Il progetto principale di Caritas Gibuti era, e lo è ancora, a sostegno dei bambini di strada. Si tratta di minori stranieri non accompagnati, quasi tutti provenienti dall’Etiopia. Con loro avevo iniziato un percorso di reinserimento non solo in Gibuti, ma anche in Etiopia, al fine di fornire qualche strumento e qualche opportunità per intraprendere un percorso di vita dignitoso. Dopo una prima fase di ascolto e comprensione, cercavo di capire quale fosse il loro progetto di vita e cosa potessi fare io per loro. Ogni bambino ha esigenze e specificità differenti e quindi non esiste una soluzione che vada bene per tutti. Il mio ruolo da Casco Bianco era quello di ascoltare tre volte a settimana i bambini e i ragazzi e cercare di capire che cosa proporre: un ritorno in Etiopia o un reinserimento nella vita di Gibuti, nelle scuole o, per i più grandi, nel mondo del lavoro. Nel momento in cui i bambini iniziavano ad aprirsi e a raccontarsi, io diventavo per loro un punto di riferimento e al contempo mi ci affezionavo, provavo empatia ed emozione suscitate dalle loro storie. Per me è stato molto difficile staccarmi da loro. Una volta terminato il mio anno da Casco Bianco, sono rimasta in Gibuti per conto mio: ho trovato lavoro, non dipendevo più da Caritas, dalla Chiesa, ma evidentemente il destino voleva che rimanessi a Gibuti legata all’ambito Caritas. Nel 2016, infatti, a un anno dallo scoppio della guerra in Yemen, sono iniziati ad arrivare tantissimi rifugiati in fuga dal conflitto. Allora il vecchio direttore di Caritas Gibuti, sapendo che ero laureata in studi arabo-islamici, mi ha chiesto di occuparmi delle donne yemenite. Così abbiamo messo su un progetto di accoglienza e integrazione per le donne e i bambini. Adoro lavorare con donne e bambini: penso siano loro la vera chiave del cambiamento».

«Nel momento in cui i bambini iniziavano ad aprirsi e a raccontarsi, io diventavo per loro un punto di riferimento e al contempo mi ci affezionavo. Per me è stato molto difficile staccarmi da loro»
Quali sono state le difficoltà che hai incontrato nel tuo cammino?
«Io sono una ragazza europea, cattolica, non sposata che vive in un Paese islamico: una delle prime difficoltà è stata proprio questa. Ogni volta, quando passeggiavo, ero vittima di aggressioni verbali, perché ero bianca e tutti sapevano che lavoravo per la Chiesa. Questo è ciò che mi è rimasto più impresso. Spesso eravamo insultati perché non riuscivamo a offrire l’aiuto richiesto. Ciò accadeva non perché non volessimo farlo, ma perché in quel momento non ne avevamo la possibilità. Vedere che i nostri beneficiari, nonostante tutto l’aiuto ricevuto, anche per un solo rifiuto ti sputavano addosso e ti insultavano è stato duro da accettare e superare. Un’altra difficoltà che si è presentata nei primi periodi in cui ero in Caritas Gibuti è legata al fatto che inizialmente venivano accolti bambini particolarmente frustrati, poiché vittime di ogni sorta di violenza, arrestati e accompagnati alla frontiera in quanto migranti irregolari. Questi bambini avevano tantissima rabbia dentro e ricordo che per i primi due anni siamo stati vittime di aggressioni anche da parte loro. Ci lanciavano pietre e ci minacciavano, perché avevamo tolto loro la colla, la droga dei poveri».
«Questi bambini avevano tantissima rabbia dentro. Ci lanciavano pietre e ci minacciavano, perché avevamo tolto loro la colla, la droga dei poveri»
Gli aspetti più belli della tua esperienza di servizio nelle terre del Corno d’Africa?
«Qui mi sono riavvicinata un po’ di più alla Chiesa. Non perché fossi obbligata ad andare a Messa, ma perché in queste terre ho vissuto, e continuo a vivere, delle situazioni alle quali non riesco a trovare risposte immediate. Un episodio significativo nel mio riavvicinamento alla Chiesa è stato nel 2017, quando ho visto morire una bambina. Avevo assistito alla sua nascita due anni prima. Era una bambina malnutrita. È stata violentata e dopo qualche giorno è morta. Io non riuscivo a trovare una spiegazione a questo avvenimento terribile. Ero veramente molto arrabbiata. Ho trovato conforto nella preghiera. Non aveva senso la violenza che era stata perpetrata a questa bambina. Forse ho intravisto un senso dopo qualche anno, quando la mamma della bambina è morta di tubercolosi, lasciando due figlie orfane. Ora mamma e figlia riposano insieme in pace. Questi episodi e le esperienze nel Corno d’Africa mi hanno avvicinato alla Chiesa e a Dio. Mi hanno anche insegnato a vedere le cose da un’altra prospettiva e a vivere in maniera diversa la vita. Scoprire che tanti ragazzini, pur non avendo nulla, sono felici, mi fa riflettere. Io mi lamento per qualcosa che non ho, mentre loro non hanno nulla e sono felici».
Il Gibuti è un Paese che ti è rimasto nel cuore. Come lo racconteresti a una persona che non lo conosce?
«Gibuti è un Paese che mi è rimasto nel cuore per gli incontri che ho fatto. Gibuti è una terra in cui la tua mente, la tua vita si aprono al mondo. Puoi incontrare chiunque qui: puoi trovare il povero che viene dall’Etiopia, il povero gibutino, gli espatriati, che hanno un ricco bagaglio di esperienze alle spalle, uomini d’affari, militari di mezzo mondo, rappresentanti di innumerevoli organizzazioni umanitarie. Gibuti è davvero un crocevia dell’Africa, quasi un po’ come il centro del mondo: vivi delle esperienze che difficilmente puoi fare in un altro contesto. Gibuti è un Paese musulmano ma che tollera e integra le altre religioni, un Paese che ti consente di vivere con l’opulento stile di vita occidentale, ma che ti ricorda costantemente che la povertà è dietro l’angolo. In tutto questo ci sono loro, i miei bambini, figli di nessuno, che devono imparare troppo presto cosa sia e quanto possa essere cattiva la vita. Penso che quello che si vive qui, soprattutto con i bambini – per me sono stati dei veri maestri di vita – sia difficile viverlo in un altro posto. Io ho imparato tanto. Ora per me Gibuti è casa».

«Ci sono loro, i miei bambini, figli di nessuno, che devono imparare troppo presto cosa sia e quanto possa essere cattiva la vita»
Per imparare a leggere e comprendere una cultura diversa dalla nostra è necessario spogliarsi dei cosiddetti “bias culturali”. Sara, qual è stata la tua esperienza in tal senso?
«Prima di arrivare in Gibuti ho vissuto un’esperienza in Marocco dove ho avuto non pochi shock culturali. Ma nelle terre del Corno d’Africa sono riuscita a mettere da parte ogni sorta di preconcetto soprattutto grazie proprio alle esperienze vissute. Un esempio su tutti è quello che riguarda l’educazione familiare e il rapporto madre-figlio, profondamente diverso dal modello europeo. Tuttavia, nel momento in cui si realizza che la donna che hai davanti ha sofferto tantissimo mentre concepiva il suo bambino, poiché vittima di mutilazioni genitali, riesci a comprendere perché queste madri siano molto dure nei confronti dei loro bambini. Si pensi anche al fatto che nel primo mese dopo il parto, le madri non accettano subito i loro figli, perché questi sono visti ancora come fonte di un dolore immane. Assistere alla scena di una madre che rifiuta il proprio bambino è davvero straziante. Tuttavia col tempo ho imparato a conoscerne le motivazioni e a scoprire la cultura che motiva questi gesti. Ho imparato a capire e ad accettare. Con Caritas avevamo pensato anche di realizzare un progetto per lavorare sulla relazione tra madre e figlio. Purtroppo non è andato a buon fine…».
Oggi sei direttrice di Caritas Somalia, basata in Gibuti. Quali sfide sei chiamata ad affrontare in questa missione?
«La Somalia è un miscuglio di problemi umanitari dovuti a inondazioni, siccità, persecuzione religiosa e conflitti politico-militari interni. Operare in Somalia, come donna e come rappresentante di una organizzazione di chiara ispirazione cristiana, è impossibile oltre che estremamente rischioso. Diventa dunque molto complicato occuparsene stando qui in Gibuti e senza avere un contatto diretto con i beneficiari. Ecco perché soffro un po’ in questo ruolo: non sono una burocrate, un’amministrativa, sono una a cui piace lavorare sul campo. Non essendo fisicamente in Somalia, ci si deve affidare alle organizzazioni locali che spesso non si conoscono di persona. Per fortuna abbiamo avuto delle piacevoli sorprese. Per esempio un anno fa abbiamo intrapreso una collaborazione con l’organizzazione somala VAD che ci sta aiutando a eseguire i vari progetti legati all’emergenza siccità. La presenza di altre ONG oltre Caritas, operanti nello stesso Paese, ci spinge a intraprendere percorsi di collaborazione che spesso non sono così scontati come si pensa e mi ha consentito inoltre di conoscere tanti giovani e tante donne somale che credono ciecamente nel loro lavoro umanitario e sono pronti a dare la vita per aiutare chi ha più bisogno».
«Operare in Somalia, come donna e come rappresentante di una organizzazione di chiara ispirazione cristiana, è impossibile oltre che estremamente rischioso»
Chi era Sara prima di diventare Casco Bianco e chi è Sara oggi?
«Prima di diventare Casco Bianco ero una ragazza che metteva al primo posto gli altri, dimenticandosi spesso di sé stessa. La Sara di oggi è sempre al servizio dei più poveri e vulnerabili, ma ha anche imparato a ritagliarsi dei momenti di riflessione. Io credo che ci sia una differenza fondamentale tra il lavoro degli operatori Caritas (missionari) e il lavoro delle altre ONG. Siamo tutti quanti mossi dalla volontà di aiutare i più bisognosi, senza recare danno ulteriore e con l’obiettivo di migliorare la loro situazione, ma noi cristiani vediamo nel prossimo veramente il volto di Cristo e questo ci rende diversi dagli altri. I momenti di riflessione mi aiutano a rafforzare questa mia visione, capire in cosa posso migliorare e ovviamente prendere la forza per continuare la mia missione. La Sara di oggi è anche molto più diplomatica rispetto al periodo iniziale in cui ero Casco Bianco. Ha capito l’importanza del compromesso e della pazienza. In Paesi come Gibuti e Somalia, i risultati si vedono a distanza di anni. Per esempio, ricordo bene che nel 2015, a Gibuti, il tema dei bambini di strada era ancora un tabù. Solamente nel 2018, dopo anni di lavoro di advocacy fatto da Caritas Djibouti, la tematica è diventata centrale per il Ministero della Famiglia e della Donna. Questo per me è un grandissimo risultato che Caritas può rivendicare con orgoglio».
Sara Ben Rached, oggi hai sulle spalle un bagaglio ricco di esperienze. C’è qualche scelta che rivedresti, qualcosa che affronteresti in modo diverso?
«Io non rivedrei nulla, perché ogni mia scelta mi ha portato sin qui. Ho sempre avuto la fortuna di fare quello che ho voluto, in piena libertà e autonomia. Ovviamente non è sempre stato facile e non lo è nemmeno ora. Inseguire i propri sogni spesso conduce a percorrere sentieri in cui predomina la solitudine. Però ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno sostenuto e mi restano vicine, incoraggiandomi ad andare avanti, nonostante spesso le mie scelte non appaiano del tutto razionali. La voglia di mettermi a servizio del prossimo continua a essere il faro che illumina il mio cammino. Dove mi porterà non lo so, ma sarà una bellissima scoperta».
«La voglia di mettermi a servizio del prossimo continua a essere il faro che illumina il mio cammino. Dove mi porterà non lo so, ma sarà una bellissima scoperta»