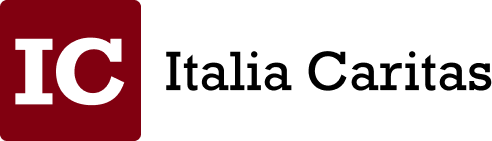Il più giovane non trova pace

Il Sud Sudan ha raggiunto l’indipendenza il 9 luglio 2011 con uno storico referendum. Sono passati 10 anni da quell’alba, che ancora molti ricordano come piena di speranza ed entusiasmo, dopo il lungo percorso della doppia indipendenza, dall’impero britannico prima e dal Sudan poi, ottenuta combattendo due guerre e aver sopportato un sempre più strategico isolamento.
Il potenziale del territorio del 54° stato africano, il paese più giovane al mondo, quanto a data di istituzione, è sempre stato enorme. Ma sin dalla nascita della repubblica si sono prospettate sfide improbe: grande e diffusa povertà, grave carenza di infrastrutture per comunicazioni e trasporti, pochissime scuole e ospedali, di conseguenza sistemi educativi e sanitari fragilissimi. Sin dall’inizio ha pesato anche la mancanza di strutture per la raffinazione e l’esportazione del petrolio, risorsa potentissima di cui il sottosuolo è ricchissimo, rimaste concentrate in territorio sudanese.
A questo quadro poco incoraggiante si contrapponevano le aspettative di una popolazione dilaniata dal conflitto, ma che confidava nei proventi dall’esportazione del petrolio, finalmente libero da ingerenze esterne, per reinvestire in un’economia diversificata e costruire un sistema nuovo, in grado di garantire i servizi di base. L’illusione della pace, però, è durata poco: dopo due soli anni di apparente calma, durante i quali si sono erosi tutti i legami che avevano unito forze diverse per una libertà comune, si è giunti allo scoppio di una violentissima guerra civile.
Il paese, insomma, è riuscito a costruire ben poco, in un decennio, a causa del continuo alternarsi tra scontri aperti e violenti e periodi di calma apparente ma mai davvero liberi da violenze. Ci si è trascinati tra accordi di pace firmati e poi violati e infiniti appelli al dialogo, in un clima di scontento generale, fino alla firma della Dichiarazione di Roma del gennaio 2020 e alla formazione di un governo di unità nazionale nel febbraio dello stesso anno (R-TGoNU).
Il paese è riuscito a costruire poco. Ci si è trascinati tra accordi di pace firmati e poi violati e infiniti appelli al dialogo, fino alla Dichiarazione di Roma (gennaio 2020)
Solo spartizione del potere
Quali sono ora le prospettive di un percorso di pace pensato per arrivare a nuove elezioni attraversando diverse fasi? Quale è stato il clima in cui i sudsudanesi hanno celebrato i primi 10 anni anni di indipendenza? Sicuramente la pandemia ha indebolito molto un sistema già fragilissimo, ma non è il problema principale da affrontare, e al quale addebitare fallimenti e successi di un percorso faticoso, una pace a singhiozzo.
Come ha recentemente dichiarato in un’intervista Betty Bigombe, inviata speciale in Sud Sudan per l’Uganda, «la pace non c’è ancora definitivamente, ma le armi sono almeno quetate». Permangono scontri e violenze, ma lo scenario è cambiato dai giorni della guerra civile. Il processo di pace sta faticosamente facendo progressi perché in precedenza ci si era sempre concentrati sulla spartizione del potere tra le diverse parti in conflitto, ma non si era mai prestata adeguata attenzione all’analisi di tutti i problemi del contesto, con una visione più ampia. Anche le ripercussioni a livello regionale sono state tralasciate, così come già in passato; più volte si è corso il pericolo che la guerra interna ai confini sudsudanesi si allargasse in tutta la regione, già segnata da equilibri precari.
Ovviamente arrivare alle elezioni senza una preparazione adeguata presenta molti rischi. Ancora oggi in Sud Sudan non vi sono istituzioni pienamente funzionanti, non c’è un esercito unito e le forze armate sono ancora in balia di dinamiche che riproducono gli strascichi della guerra.
E allora viene naturale chiedersi: come si potrebbe garantire la sicurezza di tutti durante il voto? Non è un mistero che la sfida più grande, in tutto il continente, è avere elezioni libere e imparziali, dando l’opportunità a tutti i cittadini di conoscere i propri diritti e doveri, per scegliere in piena autonomia e indipendenza i propri leader.

Nel caso del Sud Sudan ci sono forti dubbi anche sul parlamento. Già non era chiaro se fosse veramente pronto ad affrontare la tornata elettorale, per poi ripartire verso un nuovo ciclo, lavorando unito per affrontare le sfide che il paese deve ancore vincere. Ma addirittura, con grande sorpresa di molti, il presidente della Repubblica, Salva Kiir, con un discorso alla televisione pubblica ne ha annunciato lo scioglimento lo scorso 8 maggio. Il passaggio era previsto dagli accordi di pace del 2018, per consentire la sua ricostituzione con esponenti di tutte le parti avversarie nella guerra civile. Come ha riportato Al Jazeera, «attivisti e gruppi della società civile hanno accolto con favore lo scioglimento del parlamento, dicendo che era atteso da tempo, ma esprimendo nel contempo sfiducia. La società civile è frustrata e non crede più che, anche se sarà ricostituito, sarà un parlamento vitale». Senza eccessivi ottimismi, vi è solo da sperare che questo passaggio costituisca un primo passo per ridare impulso al processo di pace, rimasto sostanzialmente fermo dopo che Kiir e il suo avversario Riek Machar hanno formato un governo di coalizione il 22 febbraio 2020, con quasi un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dagli accordi di pace. Da allora, pochissime disposizioni previste dagli accordi sono state rispettate. E molti analisti internazionali hanno segnalato il pericolo di un ritorno alla guerra.
Carestia dilagante
Se è vero che le armi fanno molto meno rumore, purtroppo il paese rimane sempre in fondo alle classifiche dell’Indice di sviluppo umano (185° su 189 nel 2020) e mal gestito. Tra le molte le preoccupazioni sul futuro del paese, alcune riguardano più direttamente l’immediato. Preoccupa la carestia in corso, dovuta non solo agli schock climatici, ma soprattutto alla corresponsabilità delle azioni umane, e ovviamente inasprita dagli effetti della pandemia. Secondo il sistema internazionale di allerta per la carestia (FewsNet), già a marzo 2021 per alcune aree del paese, tra cui la Greater Pibor Administrative Area, il nord di Bahr al-Ghazal e Warrap, l’allerta era alta.
I livelli di malnutrizione ad aprile si mostravano ancora acuti, come ha denunciato l’Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, riportando che 8,3 milioni di persone, su poco più di 11 milioni di residenti censiti, necessitavano di assistenza umanitaria. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, erano 800 mila persone in più. Le persone in forte stato di malnutrizione potrebbero arrivare a 7,2 milioni entro luglio, i bambini a 1,4 milioni.
La diffusione della violenza resta comunque il cruccio maggiore del paese. Nonostante l’accordo di pace, i conflitti tra comunità, dovuti anzitutto alle incursioni per accaparrarsi bestiame, continuano, tanto da arrivare a causare mille omicidi negli ultimi sei mesi del 2020. E poi ci sono le violenze su uomini, donne e bambini, dovute ad azioni di soggetti criminali. Un grave fatto di cronaca, negli scorsi mesi, ha inaspettatamente riacceso i riflettori anche della nostra informazione sul Sud Sudan: nella notte tra il 25 e il 26 aprile, il vescovo appena nominato per la diocesi di Rumbek è stato aggredito in casa, riportando gravi ferite da armi da fuoco alle gambe. Padre Christian Carlassare, missionario comboniano, in Sud Sudan da molti anni, era appena arrivato a Rumbek dalla diocesi di Malakal. Aveva speso parole di sostegno ai giovani, in favore della riconciliazione e per la pace non solo nella diocesi, ma per l’intero paese. Aveva dichiarato a Nigrizia, periodico dei Comboniani: «Sogno che i giovani del Sud Sudan possano realizzare i loro sogni, che non siano costretti a darsi alle armi o a lasciare il paese, che possano studiare e trovare un lavoro che costruisca il futuro e dia stabilità al paese. Sogno che le giovani ragazze del Sud Sudan possano emanciparsi e non essere totalmente dipendenti dai rispettivi capifamiglia e che possano fare le proprie scelte in libertà».
«Sogno che i giovani del Sud Sudan possano realizzare
i loro sogni, che non siano costretti a darsi alle armi
o a emigrare, che possano studiare e trovare un lavoro»
L’agguato di cui è stato vittima ha scosso il paese e la Chiesa locale, anche perché è stato seguito da arresti anche tra le persone che lavorano nella diocesi. La vicenda, per fortuna in via di superamento sul versante sanitario, è eloquente esempio di quanto le dinamiche sudsudanesi siano contorte, e di quanto sia ancora lunga e impervia la via verso la riconciliazione e la pace.
Il vescovo Carlassare, pur dai centri sanitari dove è stato ricoverato per le cure e la riabilitazione, non ha cessato di spendere parole e impegno per il perdono e il dialogo. Rivolgendosi a tutte le comunità sud sudanesi, ha dichiarato di pregare perché non perdano la speranza e possano «sognare in grande e lasciare da parte tutta la rabbia, lo scontento e l’insoddisfazione che viene dal conflitto e da una catena di violenza che non ci permette di sperare in un mondo altro, dove chi vince è sempre il più forte, dove per ottenere qualcosa bisogna lottare. […] Bisogna riscoprire i valori belli dell’Africa, della famiglia, della solidarietà, della comunione, della pace», che anche il Sud Sudan sperimentava, prima della storia di conflitti e violenze che lo ha crocifisso negli ultimi 50 anni».
Aggiornato il 19/10/21 alle ore 13:07