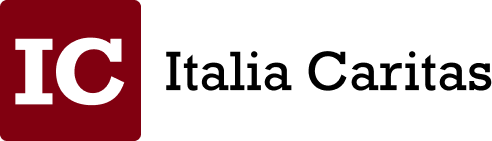Ripartire. Col piede giusto

Tutti abbiamo letto, nello scorso luglio, almeno qualcuno tra i molti articoli e commenti scritti su quel che è accaduto, nell’aprile 2020, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini su quelle inaudite violenze, perpetrate ai danni di detenuti che avevano inscenato proteste per chiedere protezione contro il rischio di diffusione del Covid, si sono peraltro intrecciate, in estate, al dibattito scaturito dal primo dei passaggi parlamentari della riforma Cartabia del processo penale. Lo scoperchiamento delle violenze ha prodotto un’ondata di indignazione nel paese. Tanto che c’è da chiedersi cosa abbia infine prodotto quella giusta indignazione, così ampia ed eterogenea.
Ma cosa resta oggi delle riflessioni espresse, con diverse argomentazioni, da chi ha assistito sgomento alle palesi violazioni del diritto, all’esercizio violento dell’autorità, alle umiliazioni inflitte, alle percosse, al crescere e moltiplicarsi della violenza?
Quello su cui dovremmo oggi interrogarci è se un sistema carcerario inteso come la principale, se non l’unica, risposta ai problemi dei reati, dell’espiazione e della sicurezza sia davvero necessario e opportuno. Il sistema non funziona, è chiaro: il rapporto fra controllori e controllati non è sano, il potere esercitato così brutalmente non genera calma, non pacifica, anzi agisce in una spirale di violazioni burocratiche, sanitarie, sociali, che serrano la morsa su rapporti sempre più difficili e tesi.
Il sistema carcerario inteso come la principale, se non l’unica, risposta ai problemi dei reati, dell’espiazione
e della sicurezza, è davvero necessario e opportuno?
Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che la separazione (del reo) non cura, l’isolamento non guarisce, l’allontanamento dagli affetti genera tensione e malessere. Eppure, se scrutiamo nel lavoro delle madri e dei padri costituenti, vediamo che la loro scrittura, certamente resa saggia da ciò che avevano vissuto sulla propria pelle, era stata previdente: all’articolo 27 della Costituzione non si parla di un’unica pena, e men che meno di carcere; sono “le pene”, in tutta la loro complessità, a essere rammentate, come plurime forme di esecuzione.
Le alternative portano benefici
Ci chiediamo, allora, cosa sia successo al nostro paese. Perché, in così breve tempo, il pensiero della punizione – sempre per primo, seguito solo in secondo luogo da quello della rieducazione – ci fa subito pensare alla prigione, luogo privilegiato in cui segregare e allontanare persone, pensieri e preoccupazioni. Le forme dell’esecuzione penale possono invece essere molte e diverse, e quelle già sperimentate come alternativa al carcere hanno dimostrato di portare benefici per tutti, in termini di sicurezza, efficacia e – perché no? – anche di risparmio economico.

Il fallimento di questo carcere, di questa idea della reclusione così recente, così pervasiva e così apparentemente convincente è avvalorato dal fatto che ciò che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere non è un evento isolato, come dimostra la quindicina di processi in corso per fatti simili, e come è stato più volte intuito dai volontari penitenziari nel loro operato presso gli istituti. Eppure è proprio dai volontari che apprendiamo anche di azioni meritevoli svolte da parte della polizia penitenziaria, con la quale essi spesso collaborano per rendere possibili veri e propri percorsi di rieducazione.
Responsabilità non delegata
Allora la vera domanda che osiamo porci è la seguente: quale coraggio ci manca per ammettere che è il sistema a non funzionare? Abbiamo superato un limite, abbiamo visto qualcosa che non è solo esecuzione della pena, ma che assomiglia più alla vendetta e alla sopraffazione, ed è quindi giunto il tempo di affrontare questo interrogativo.
Riappropriarci di un ruolo autonomo della società civile
riguardo all’esecuzione delle pene; ipotizziamo insieme un nuovo modello di esecuzione penale
Esiste un limite invalicabile, ce lo vogliamo ripetere. Accettiamo che lo Stato – esso solo – possa limitare la libertà, soltanto a patto che venga preservata integra la dignità degli esseri umani. Possiamo infatti accettare le limitazioni dei lockdown, perché la nostra identità di cittadini, lavoratori e persone viene garantita. Ma là dove la garanzia della dignità si perde, occorre opporsi.
Questo tipo di carcere ha bisogno della nostra obiezione e della nostra azione. Il reato, la colpa, la pena, riguardano tutti. Iniziamo a riappropriarci di un ruolo autonomo della società civile nel contesto dell’esecuzione delle pene; informiamoci, formiamoci, partecipiamo, non restiamo in silenzio. Ipotizziamo insieme un nuovo modello di esecuzione penale, rispetto alla quale la parola cardine sia “responsabilità”. Una responsabilità condivisa da tutti, secondo i propri ruoli, non delegata. Facciamo nostri modelli di pena differenti, per sperimentare concrete possibilità di dialogo e ripartire, nella questione penale, alla vigilia del varo di una importante riforma, con il piede giusto.
* Caritas Ambrosiana – vicepresidente Conferenza nazionale volontariato e giustizia
Aggiornato il 13/10/21 alle ore 13:02