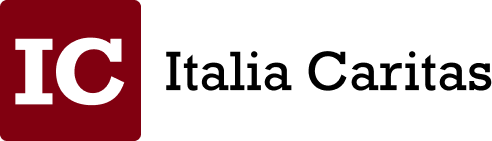Il continente con il bavaglio

Lo sa benissimo Chandima – che da anni guarda il cancello in attesa del ritorno di Dilip e Chatu, marito e figlio – che la verità è un animale strano, difficile da addomesticare, irruento e feroce e per questo tenuto saldamente rinchiuso nelle gabbie della confusione processuale.
Lo sa ma non sa dirlo: il suo mutismo è abissale da quella Pasqua del 2019, quando chiese e hotel di lusso dello Sri Lanka – templi religiosi e secolari insieme – furono distrutti da una violenza mai vista e da attentatori senza freno.
Chandima ha deciso, dentro di sé, in un angolo inaccessibile della mente, che ogni parola sarebbe stata di troppo, e che davanti a fiumi in piena di accuse, controaccuse, bugie e alibi grotteschi solo il silenzio avrebbe reso giustizia alla sua attesa di affetti destinati a non varcare mai quel cancello.
La via opposta a Chandima l’ha scelta Shehan, giovane uomo divenuto attivista per la verità proprio in seguito agli attacchi. Ha scelto di esporsi, Shehan, convocando una conferenza stampa affollata e lunga in cui ha accusato apertamente – con dati alla mano – il presidente in carica nel paese, quello procedente e una serie di persone influenti tra politici e militari, di nascondere la verità, di manipolare le informazioni, addirittura di aver ordinato in qualche modo gli attacchi alle chiese cristiane, attribuiti a formazioni terroriste di matrice islamista.
È stato arrestato dalla polizia investigativa, Shehan Malaka Gamage, con il beneplacito del procuratore generale, e rilasciato su cauzione poche ore dopo.

Shehan, a differenza di molti altri attivisti, però, non è solo: una tra i più decisi e determinati nel chiedere serietà, verità e giustizia è il cardinale Malcom Ranjith, arcivescovo della capitale Colombo. Da anni si batte con fierezza, promuovendo indagini parallele, raccolte di testimonianze, conferenze stampa e colloqui individuali, per ricostruire la verità dei fatti e dare dignità alle vittime degli “attacchi di Pasqua” .
* * *
Lo Sri Lanka è solo uno dei casi di libertà negata o imbavagliata a intermittenza in Asia.
Il continente si trova nella parte bassa della classifica – Indice mondiale della libertà di stampa – stilata annualmente da Reporters sans frontiers (Rsf). Alcune nazioni, in particolare, ovvero Laos, Brunei, Singapore e Vietnam, stazionano stabilmente sotto al 150° posto, su un totale di 180 paesi al mondo.
Nonostante la maggior parte dei paesi asiatici formalmente si dichiari a favore della libertà di espressione, molti di essi hanno approvato e approvano leggi che di fatto limitano le libertà e il dissenso rispetto alle decisioni dei governi.
Restrizioni con pretesto sanitario
Lo sa bene Peter, un commerciante e fedele cristiano presente nel Satprakashan Sanchar Kendra Christian Center nella città di Indore, brutalizzato dalla violenza dell’estremismo Indu nel gennaio dello scorso anno.
Peter ha rilasciato interviste alle televisioni locali, ha registrato qualche messaggio per Facebook ed è stato interrogato, picchiato, incarcerato e minacciato prima di essere rispedito a casa, dolorante e fiaccato nello spirito.
Phayvanh invece ha osato, nella sua campagna laotiana, criticare la modalità di assegnazione dei benefici economici da parte degli amministratori locali. Un incontro tra persone ritenute amiche, un bicchiere di troppo, una discussione scivolosa sul terreno della politica e dei benefici per i contadini dalla schiena piegata nei campi, una protesta contro la distribuzione delle sementi e dei fertilizzanti, il desiderio di affermare i diritti suoi e dei propri compaesani… Niente video, nessuna intervista, men che meno conferenze stampa, nessun post online (anche perché Phayvanh un telefono non ce l’ha), niente bandiere di affiliazione politica. Eppure quelle poche parole condite di verità e alcol sono bastate a Phayvanh e a suo figlio minorenne per vincere due notti in una cella umida e muffosa, per guadagnare qualche frattura, una decina di ecchimosi e migliaia di minuti di terrore.

Anche Maria conosce benissimo il prezzo dell’esporsi in favore della verità, di un punto vista diverso, di un’idea. Maria Ressa, giornalista, ora premio Nobel per la Pace 2021, ha subito più volte tentativi di imbavagliamento da parte del presidente delle Filippine e lo sforzo per la verità, per l’espressione del dissenso e per un’informazione trasparente è divenuta una lotta anche per l’incolumità personale.
* * *
La crisi mondiale causata dalla pandemia da Covid 19 ha portato, a livello globale, a un assottigliamento delle libertà di espressione e dissenso. E ciò non solo in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, ma anche per l’uso indiscriminato del potere da parte di molti governi, che hanno colto l’occasione delle restrizioni socio-sanitarie per un inasprimento del controllo sulla libertà delle popolazioni.
In Asia la Cina è un capitolo a sé, nella misura in cui anche prima della pandemia le restrizioni alla libertà di espressione diretta o via social media costituivano un tema forte e presente; in seguito alla pandemia, le stesse hanno preso una piega del tutto particolare, legata anche alle modalità di contrasto dell’emergenza che il governo cinese ha posto in essere sin dalle prima fasi.
Ma, al netto della Cina, anche in diversi altri paesi del continente, tra cui alcuni molto influenti, gli scenari tracciati dalle restrizioni su base sanitaria sono divenuti angusti, tortuosi e talvolta marcatamente censori.

L’India, ovvero l’altro gigante della regione, con il suo leader Narendra Modi – nazionalista dichiarato –nel corso degli anni ha ristretto di molto le libertà di dissenso ed espressione: la rivolta dei contadini, per fare un esempio recente tra i molti, ha dato il là alla messa in opera di quanto progettato e preparato per anni. La disputa tra governo centrale e twitter ha fornito l’occasione di una censura grave e importante; con le minacce di carcerazione, Modi e i suoi hanno di fatto ottenuto la rimozione di migliaia di post ritenuti lesivi della democrazia.
Le nuove regole del governo indiano, che riguardano tutte le piattaforme social, di fatto sono il chiaro segno di un controllo autoritario con lo scopo, secondo i governanti, di “evitare abusi e malusi dei social media”. Chiaramente, però, ciò avviene attraverso quello che può essere letto esso stesso come un abuso. Una delle regole impone, ad esempio, l’indicazione di un referente nazionale, ovvero di nazionalità indiana, della piattaforma: ciò da un lato evita l’impossibilità di perseguire eventuali violazioni, nella ragnatela di sovrapposizioni nazionali e transnazionali che caratterizzano internet e le società che operano nel mondo digitale, ma d’altro canto impone molto chiaramente, de facto, un livello elevatissimo di controllo, in una nazione in cui le violazioni in “area internet” sono tenute sotto controllo con costanti minacce, controlli e intimidazioni.

Anche la Tailandia, il Vietnam, il Laos, Timor Est, le Filippine e altre nazioni hanno visto le proprie libertà di espressione ridursi durante la pandemia, a cospetto di un esponenziale aumento di esposizione e collegamento alla rete internet; inoltre la sicurezza dei giornalisti è diminuita – a causa di fattori diversi – di circa la metà.
Infine anche molte altre nazioni asiatiche hanno considerato e considerano tuttora la pandemia e il cambiamento epocale – utilizzo dei media, possibilità di controllo, accesso ai dati – da essa generato, come alibi per una presenza massiccia e minacciosa dei governi contro le opposizioni.
Il popolo non sa da che parte stare
Continua nel suo silenzio ostinato Chandima, guardando il cancello e la certezza che nessuno entrerà. Continua nella sua battaglia personale e sociale Shehan, inviando video via facebook anche dall’interno del furgone bianco – il famigerato white van, terrore simbolico di tempi che si pensavano passati – subito dopo l’arresto.
E fatica il popolo, somma di singoli individui spesso sapientemente tenuti divisi, a non sapere da che parte stare, mentre governanti autoritari continuano a silenziare le voci e le diversità di opinione.
Aggiornato il 04/03/22 alle ore 16:19