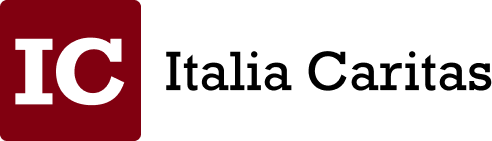La guerra vista dagli occhi dei bambini

War Childhood Museum. Uno straordinario progetto museale ideato nel 2017 da Jasminko Halilovic, un 34enne bosniaco che ha vissuto la sua intera infanzia sotto l’assedio di Sarajevo. Ha ideato l’iniziativa quasi per caso, alcuni anni fa, con una semplice domanda su Facebook, da raccontare in un massimo di 160 caratteri: «cos’è stata per te la guerra?». Gli risposero in diecimila ex bambini che avevano vissuto la tragica esperienza della guerra, aprendo il vaso di Pandora dei loro ricordi, condividendo per la prima volta esperienze intime di dolore e morte ma anche di gioia e speranza. In poco tempo centinaia di persone gli portarono anche piccoli frammenti dimenticati della loro infanzia. Vestiti, lettere, giochi, testimonianze, foto e video di famiglia, alcuni risalenti agli anni felici prima della guerra e poi custoditi gelosamente come un tesoro personale. Poiché quando si è costretti a stare in bilico tra la vita e la morte anche i piccoli oggetti del “prima” possono un fornire un conforto, infondere fiducia nel futuro, diventare un antidoto all’angoscia e alla disperazione.
A raccontare l’esperienza del War Childhood Museum è Amina Krvavac, direttrice esecutiva del museo di Sarajevo, ospite del 42esimo Convegno nazionale delle Caritas diocesane a Milano in occasione dell’incontro “Note di Pace”.
Come è nato il tuo coinvolgimento nel museo?
È successo nel 2014 in seguito a un incontro con Jasminko, con cui sono amica da anni. Un giorno mi ha invitato in un caffè di Sarajevo, la nostra città e mi ha raccontato la sua idea di realizzare un museo dedicato all’infanzia vissuta in tempo di guerra. L’idea inizialmente mi sconvolse perché quell’infanzia riguardava da vicino, forse troppo vicino, anche me. Mi ricordo il disagio provato durante quell’incontro, non mi sentivo ancora pronta a riaffrontare certi temi, a prendere in mano quel dolore. Era troppo difficile.
“Avevo già vissuto la guerra da bambina e non mi andava di riviverla. Avevo già fatto la mia parte”
Infatti quando eravamo al caffè Jasminko mi regalò il libro da lui scritto, quello che conteneva le frasi e i ricordi di tanti uomini e donne che sono stati bambini come me durante l’assedio di Sarajevo… Non sono riuscita a leggerlo per diverso tempo.
Poi cos’è successo?
Abbiamo continuato a parlare di questo progetto e giorno dopo giorno cresceva in me l’interesse. Un progetto che nel 2015 è diventato una realtà concreta e ha coinvolto da vicino me, che sono un’esperta di diritti dell’infanzia a livello internazionale, Jasminko che è un economista e un’altra nostra collega, antropologa. È stato interessante vedere come con naturalezza le nostre vite, le nostre competenze si siano allineate verso un obiettivo comune. Prima di avere concretamente la struttura fisica museale, abbiamo iniziato a raccogliere testimonianze video, e gli oggetti più rappresentativi per i bambini: quasi 2000 oggetti personali e circa 100 ore di girato di interviste.
Giorno dopo giorno è cresciuto in me il desiderio di dare la voce, attraverso il racconto di chi è sopravvissuto, agli oltre 1600 bambini che nel corso dei 44mesi di assedio persero la vita a Sarajevo.
C’è stato un momento preciso in cui mi sono resa conto del bisogno di condividere e rielaborare i miei sentimenti, attraverso i ricordi non solo miei ma di tutti i bambini di Sarajevo.
C’è una storia che ti ha particolarmente colpito?
Difficile dirlo, perché ogni storia raccolta contribuisce ad avere chiaro cosa significa essere bambini in tempo di guerra. Tutte le storie mi hanno colpito. Posso però dire che per me è stato molto difficile raccogliere le testimonianze dei minori sopravvissuti allo sterminio di Srebrenica, così come ascoltare il racconto delle donne, un tempo ragazze negli anni ’90, vittime di stupri, molto di loro diventate madri dei figli nati dalle violenze. Sono racconti fondamentali, perché non fanno abbassare la guardia. La guerra non è un unicum: può ripetersi. E l’Ucraina ne è un esempio concreto.
Posso chiederti se tu e gli altri due responsabili del museo avete donato alcuni dei vostri oggetti?
Sisì, ne abbiamo donati diversi ! Per testare la metodologia prima abbiamo raccolto le nostre testimonianze video, per capire se “funzionavano”, poi abbiamo raccolto i nostri oggetti che però non sono finiti nella mostra permanente perché volevamo dare più spazio alle storie degli altri. È normale che ognuno di questi ex bambini porti i suoi amici, genitori, parenti al museo per condividere il suo vissuto: durante la mostra sono esibite 50 storie, 50 oggetti che ogni anno cambiano per dare spazio a tutti.

Ma cosa hai portato di tuo?
C’è un giocattolo che per me è stato importante. I negozi durante la guerra ovviamente non erano aperti, neanche c’erano i soldi per comprarli… allora la mamma della mia più cara amica ha rimediato qua e là pezzi di tessuto, diversi materiali, come bottoni e cartone e mi ha regalato un pupazzo cucito da lei per il mio compleanno. Sai la creatività andava forte in tempo di guerra. Poi avevo con me diverse foto, scattate durante la guerra che abbiamo mandato ai nonni in Germania, per far loro sapere che stavamo bene. Ascoltando tanti bambini, tante esperienze, mi ritengo fortunata perché non sono stata ferita e non ho perso nessuno dei miei cari. Questo non vuol dire che per me sia stato meno traumatico; ricordo bene la mancanza di cibo, di elettricità per tre anni, il correre a riparo nei bunker sotterranei della scuola ogni volta che suonava l’allarme.
La vostra intenzione è quella di creare una sorta di museo diffuso…
Sì abbiamo diverse collaborazioni con partner in ogni parte del mondo, dall’Afghanistan, all’Iraq, all’Ucraina. E proprio in Ucraina avevamo organizzato un team che doveva occuparsi di raccogliere e raccontare le esperienze dei bambini nel Donbass, dove dal 2014, si combatte una guerra. La mostra era stata già a Kiev, poi si è spostata a Kherson dove però è stata interrotta in seguito allo scoppio del conflitto. Un’altra esposizione era stata programmata per l’estate prossima a Odessa. I nostri colleghi ucraini del War Childhood Museum erano stati evacuati, ma una di loro ha scelto invece di tornare a Kiev, perché sentiva che lì era il suo posto.
Sicuramente il War Childhood Museum è un progetto di straordinaria importanza, ma assume su di sè contemporaneamente la valenza di bello e brutto. Bello perché dà voce al vissuto dei bambini, guardando alla guerra dalla prospettiva dei più innocenti. Brutto, perché il vostro museo risulterà sempre attuale a causa di conflitti, che ogni giorno scoppiano in tutto il mondo.
È vero quello dici, sono d’accordo con te. Noi pensiamo che questo museo serva per sensibilizzare le coscienze: per poter reagire in tempo, per capire che abbiamo la responsabilità di salvare i bambini in guerra , per capire che la guerra è un inutile massacro. Ma non solo. Il War Childhood Museum è anche un modo di affrontare il passato, che qui in Bosnia si fa ancora fatica guardare dopo quasi trent’anni. È utile perché rappresenta una piattaforma di dialogo che contiene la voce di uomini e donne che un tempo sono stati bambini sofferenti.