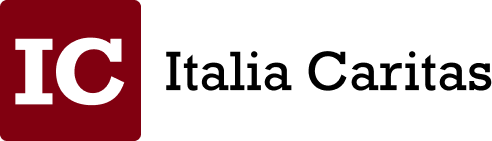I margini al centro

Lo sguardo antropologico sulle cose del mondo è sempre multidimensionale. Assegna profondità a un fenomeno, una cultura. Ne disvela tutta la complessità. È complessa per natura la realtà della frontiera. Approfondirla con l’antropologa e sociolinguista Giustina Selvelli, nata e cresciuta a Pieris, 20 chilometri da Gorizia, significa cogliere la forza provocatoria del termine “confine” in tutte le sue possibilità semantiche. Insomma, il confine, lo sappiamo, non è solo quello geografico. Ma certo formare la propria personalità in una zona di frontiera spinge a una riflessione continua sull’uso del termine in prospettiva verticale e orizzontale. Il libro della Selvelli, “Capire il confine. Gorizia e Nova Gorica: lo sguardo di un’antropologa indaga la frontiera”, per i tipi di Bottega Errante Edizioni, ripercorre le vicende che hanno diviso e unito le due città contigue, italiana una e slovena l’altra: dalla cortina di ferro dopo la Seconda guerra mondiale all’eliminazione delle dogane, dalla rete divisoria durante la pandemia di Covid-19 alla sospensiоne dei trattati di Schengen sulla libera circolazione di persone e merci, dalla rotta balcanica all’annuncio della Capitale europea della cultura 2025. Ma soprattutto il volume riflette sul confine e sui confini. Fuori e dentro di noi.
Cosa c’è nello sguardo dell’antropologo che non troviamo negli studiosi di altre discipline?
«L’antropologia riesce a far emergere la complessità dei luoghi nel loro vissuto esperienziale personale, non tacendo neanche le implicazioni soggettive, soprattutto emotive, nel vissuto concreto delle persone. Le altre discipline, le scienze sociali, come la sociologia, hanno ancora un po’ paura delle emozioni e dei risvolti personali, dell’inclusione, della stessa soggettività. L’antropologia riesce a valicare molti confini fra oggettività e soggettività, creando uno strumento complesso in cui coesistono anche visioni differenti e vissuti non sempre lineari. Ecco, l’antropologia è sicuramente uno strumento utile a non banalizzare mai i fenomeni complessi».
Dalla scheda di presentazione del libro: «Selvelli sovrappone la sua biografia personale alla storia della frontiera». Piuttosto sembrano due parti che non possono essere disgiunte. Noi siamo anche i nostri luoghi, a maggior ragione se questi luoghi sono così caratterizzati e caratterizzanti…
«Assolutamente. La geografia, il contesto ci definisce moltissimo. Per quello – forse in maniera curiosa per il lettore italiano di altrove – io definisco viscerale il rapporto di chi vive qui con la frontiera aperta, con quello che sta al di là, il mondo sloveno ma anche ex-jugoslavo, perfino quello austriaco e quindi asburgico, perché noi siamo definiti proprio da una geografia che non può semplificare il vissuto attraverso una visione nazionale, etnica oppure solo italiana. Per questo è molto importante sottolineare il valore della geografia, che poi si unisce ovviamente a quello della storia».
Quanto e come vivere in questi luoghi ha plasmato il suo interesse per l’antropologia?
«Tantissimo e me ne sono resa conto solo di recente, specialmente preparando questo libro che anni fa non avrei mai pensato di scrivere perché mi rivolgevo ad altri orizzonti, più lontani, più esotici. È stato proprio l’incontro, o anche il mancato incontro, in senso davvero pieno, integrativo con l’alterità culturale che ha determinato l’emergere di una passione per ciò che non veniva detto, e quindi soprattutto per una cultura diversa come quella slovena, che era lasciata troppo ai margini nell’educazione, nei discorsi pubblici, e perciò ci veniva sottratta la possibilità di avvicinarci a essa attraverso la privazione della possibilità di studiare la sua lingua, di essere esposti alla sua cultura, alla sua letteratura. Consideriamo che la cultura slovena non era solo la cultura del nostro vicino, ma anche quella della principale comunità minoritaria delle città di Gorizia e Trieste. Penso che siano state proprio queste dinamiche di irrigidimento a determinare la mia esigenza di trovare un approccio disciplinare e più tardi professionale con cui cercare di lenire le contraddizioni, giungere in qualche modo a una visione molto più inclusiva dello spazio culturale. Sicuramente crescere così vicino a una frontiera ha determinato tanti sconfinamenti fin da bambina e quindi questa sete, questa “dipendenza” dalla sensazione del viaggio, della frontiera aperta, della possibilità di affacciarmi immediatamente a una cultura, a un mondo diverso, esotico, la prospettiva di un altro mondo possibile».

Lei dalle zone ai margini si è spesso recata in diversi centri del mondo. Questi allontanamenti cosa hanno aggiunto, tornando, alla conoscenza dei suoi confini, dei suoi luoghi?
«Per lungo tempo ho voluto scappare da queste zone – come capita abbastanza banalmente a tutti – cercando dei centri più prestigiosi, soprattutto quelli che nel mio immaginario erano portatori di un’importante cultura urbana, sentendomi caratterizzata da un retroterra contadino, comunque non urbano. Andando in grandi città come Roma, Toronto, Istanbul ho cercato le dinamiche della complessità, della diversità culturale, del multilinguismo, del multiculturalismo. Però sono spesso stata delusa, specialmente a Roma, perché quello che mi mancava era proprio la possibilità di trovare i miei margini, che in qualche modo non si conformavano a una visione identitaria nazionale, bensì lasciavano molti più spazi di libertà e di resistenza. Il centro con il tempo è andato caratterizzandosi per me come sinonimo di omogeneizzazione, pur ovviamente con tutte le dinamiche complesse di diversità culturale che esistono; però quello che mi interessa di più è la persistenza storica a lungo termine della diversità culturale, la sua integrazione già avvenuta e quindi soprattutto le pratiche del passato, del multilinguismo e le identità non centralizzate, più libere e trasgressive. Paradossalmente ho trovato molta più eterogeneità e mancanza di conformità nei margini, che poi ho ricominciato a inseguire, ma prima all’estero. Quindi in un certo senso sono scappata di nuovo, non più nei centri ma in altre zone di confine, senza rendermi conto che subconsciamente stavo iniziando a metabolizzare tutto il mio vissuto della zona di confine italo-slovena».
Vivere di confine, tra fughe e ritorni, tra ricerca e anelito, sposta il limite più in là o può costituire esso stesso un limite?
«La percezione del limite è soggettiva: lo si può vivere come una chiusura oppure può essere qualcosa che ci fa sconfinare sempre di più perché vogliamo alzare la posta in gioco ed estendere le nostre sfide. Io ho vissuto il limite come una possibilità di miglioramento, di apertura, anche se ovviamente l’ho sempre messo in relazione con le dinamiche istituzionali che molto spesso lo vedevano come una barriera. E quindi lo imponevano come un confine, anche fisico, nella vita degli abitanti. Però mi sono resa conto di come persista sempre un dualismo fra la soggettività delle esperienze degli abitanti delle zone di frontiera – ovunque, non solo nello spazio italo-sloveno – e la possibilità da parte delle istituzioni di manipolare questi stessi confini o limiti, riducendo anche la mentalità di apertura di queste zone e quindi usandoli come una forma di spauracchio, un monito alla difesa della propria cultura, di una sorta di retorica identitaria, esclusivista, che mi dà sinceramente molto fastidio, perché riduce l’identità a qualcosa di banalizzante e del tutto anacronistico per i nostri tempi».
Ci definiamo attraverso gli altri. Ma come si definisce un sé attraverso un altro vicino che è però un po’ “più altro” perché appartiene a un Paese diverso, ha una lingua diversa, …?
«Questa alterità ci spinge a metterci in gioco. L’altro ci consente sia di diventare potenzialmente qualcosa di più, di diverso, ma anche di guardare la propria cultura con una nuova prospettiva di alterità acquisita, quindi relativizzando anche le nostre basi di partenza, rendendoci conto che ci sono molteplicità di punti di vista e di possibilità di interpretare gli stessi fenomeni. Molto spesso questo è un arricchimento, non limita la nostra capacità, il nostro benessere nello stare nelle società complesse; anzi, ci rende più preparati alle sfide del multiculturalismo, della diversità culturale. Quindi l’alterità per me è un concetto assolutamente necessario che non deve essere manipolato per creare il fantasma del diverso o la minaccia, come ultimamente sentiamo molto spesso. Secondo me nel momento in cui emergono queste retoriche, non facciamo che dimostrare, in realtà, la fragilità delle nostre stesse costruzioni identitarie. Se siamo davvero così spaventati dal perdere qualcosa, vuol dire che questa nostra identità non è poi così forte. Io non credo nell’identità esclusiva, unica. Penso che questo concetto non sia mai esistito. È una costruzione dovuta soprattutto all’emergere dello Stato-nazione, a partire dal 1800, quindi da una visione anche sulla lingua caratterizzante, definente il gruppo sociale omogeneo di uno Stato. Se guardiamo al passato ci rendiamo conto che questa non era assolutamente la condizione naturale dei popoli, soprattutto nelle zone di frontiera, non solo qui ma anche altrove. E penso agli imperi multietnici, alle pratiche di multilinguismo nelle nostre città, ma anche in piccoli centri».
Raccontare il confine può essere un rischio: lo si racconta sempre dalla propria parte. E c’è di più: una persona a un chilometro da me, che non vivo in una zona di frontiera, racconta il territorio in cui viviamo in maniera meno diversa da me rispetto a quanto faccia un suo vicino rispetto a lei.
«Certo, e la cosa fondamentale è trovare uno spazio di integrazione delle visioni diverse sulle stesse città, sullo stesso confine; in qualche modo creare uno spazio di dialogo. Ovviamente nel caso delle città di frontiera sarebbe opportuno cercare di creare le condizioni per una scrittura, un dialogo polifonico, non univoco perché, appunto, questa è la vera caratterizzazione della vita delle persone di confine. Io ho cercato di includere sia la mia soggettività, le mie emozioni, il mio vissuto, sia gli slanci e le ferite comuni e oggettivamente presenti nel vissuto collettivo degli abitanti di confine cercando di mostrare la persistenza anche in questo caso di visioni molteplici, senza voler ridurre la complessità di queste città, della loro cultura, delle loro visioni, della loro storia, delle loro memorie ed emozioni a un solo enunciato univoco e monolitico. Questo è stato il mio scopo».
Vivere in un luogo ai margini può suscitare una maggiore attenzione nei confronti di chi vive ai margini non geografici?
«Assolutamente. Io penso che anche questa sia stata una delle grandi lezioni che mi ha fornito la vita di frontiera, perché in qualche modo ci si rende conto di essere marginalizzati, messi ai margini dal centro, che non è solo territoriale, ma il centro dell’identità nazionale. Per me questo ha significato l’emergere di una volontà di rimanere ai margini, quindi di identificarmi proprio con tutto ciò che resiste sia alle dinamiche di omogeneizzazione ma anche alla vulnerabilità delle identità che non vogliono conformarsi e che in qualche modo rappresentano una ricchezza per la creazione di un’etica e una poetica della diversità. Per me è stato fondamentale proprio il contributo dato dalla mia esperienza di confine, che mi ha portato a intraprendere un percorso non solo da antropologa ma anche da studiosa delle minoranze etniche in varie zone d’Europa, soprattutto nei Balcani, come le minoranze rom. Mi rendo conto solo adesso che scrivere “Capire il confine” è stata una sorta di autoterapia o di autoconoscimento di un percorso particolare, anche soggettivo per me, e devo ringraziare le esperienze belle e quelle difficili vissute in questo confine per ciò che mi hanno insegnato e per lo stimolo che mi hanno dato a indagare, approfondire».

Lo scorso mese di aprile si è svolto il 44° Convegno nazionale delle Caritas diocesane. Titolo: “Confini, zone di contatto e non di separazione”. Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, nel tracciare le conclusioni del Convegno ha ribadito quanto sia importante “riconoscere i nostri confini, i margini che ci portiamo dentro, le esperienze di limite che definiscono la nostra esistenza, per poi accorgerci dei confini che sono fuori di noi”.
«Che bello! Condivido questa visione di mantenere aperta la frontiera, dentro di noi ma anche fuori; riconoscere quali siano le costruzioni che vengono spesso imposte dall’alto, che cercano di categorizzare, ingabbiare le identità molto più fluide, la vita libera sia della frontiera sia delle identità marginali, ma anche di molti altri fenomeni. È importante rendersi conto di come i limiti esistano per essere superati. Ringrazio l’esistenza di questi confini nella mia vita per avermi stimolata a superarli, in maniera quasi ossessiva, non solo qui ma anche altrove».
Le aree di confine possono anche essere esempio della migliore Europa?
«Secondo me negli ultimi anni stanno nascendo delle pratiche assolutamente positive di incontro fra italiani e sloveni, ma anche rappresentanti delle comunità migranti e immigrati da altre zone d’Europa, studenti internazionali. Si stanno davvero creando delle possibilità di incontro attraverso iniziative culturali, sociali, che io cito nel libro insieme ad altre buone pratiche. L’Europa è un progetto meraviglioso però viene giocato ancora troppo nei suoi centri, a livello decisionale, a livello di imposizione di dinamiche che si dimenticano proprio del potenziale di cerniera, di incontro delle zone di frontiera. Io penso che l’Europa si giochi ai suoi margini. È qui che si crea un’identità transnazionale davvero europea caratterizzata da multilinguismo, dialogo, scambio e appunto anche dagli sforzi per far coesistere memorie diverse a volte non in perfetta sovrapposizione fra di loro. Questo dobbiamo imparare per essere davvero europei. L’Europa non è quella dei collegamenti fra aeroporti, fra Roma e Vienna: la cosa più importante è proprio la lentezza dello sforzo, l’Europa che prende tempo per costruire qualcosa insieme, così come prende tempo un viaggio in treno, ad esempio fra Trieste e Klagenfurt. Con i ritmi della frontiera, diversi, un po’ più lenti, più calmi».
Piazza Transalpina, dove passa il confine tra Gorizia e Nova Gorica, tra Italia e Slovenia, da luogo di separazione, lacerazione, è diventata luogo di contatto e di iniziative che uniscono. Che cosa dice oggi a voi goriziani quella piazza?
«È un luogo molto importante e simbolico ed è in qualche modo anche stato messo in pericolo dalle politiche di chiusura, di irrigidimento dei confini, non solo recentemente dallo scorso ottobre con il riemergere dei trattati di Schengen, ma già prima: mi riferisco al caso dell’estate 2019 quando il ministro Salvini, con l’appoggio del presidente della Regione Fedriga, decisero che poteva diventare teatro di un nuovo spazio delimitato della frontiera a causa dell’inasprirsi della crisi migratoria. Gli abitanti uniti in maniera libera e spontanea si sono opposti a tutto questo. Anche se dopo qualche mese è arrivato il Covid e abbiamo vissuto un altro trauma di chiusura, di confinamento. Piazza Transalpina è come uno specchio del vissuto e delle emozioni degli abitanti di queste zone. Adesso in realtà è l’unica zona in cui Schengen non è stato ripristinato, quindi è il solo punto di frontiera che si può ancora attraversare. Ed è un luogo a noi caro, da proteggere, da non dare per scontato, perché è stato il teatro di un avvicinamento reciproco, ma anche del principale allontanamento nel Dopoguerra. Quindi è parte integrante del vissuto emozionale dei suoi abitanti. Sarebbe inconcepibile vedere delle nuove barriere fisiche, anche se sappiamo, purtroppo, che queste potrebbero emergere di nuovo. È come un organo pulsante la cui circolazione non deve essere ostacolata. Teniamo a questa piazza come se fosse una creatura viva».
Nova Gorica e Gorizia insieme capitale europea della cultura 2025. Tra le iniziative che saranno promosse, ce n’è una a cui tiene particolarmente?
«Ne cito due: La prima è una sorta di ambulanza cinematografica che andrà nei villaggi di frontiera. Il progetto è di Anja Medved e Nadja Velušček, due registe che si sono sempre dedicate a narrare la frontiera, e raccoglierà materiale orale presso le generazioni più anziane per ricordare alcuni dei vissuti più importanti di questa frontiera attraverso il tempo. Non solo nell’immediato dopoguerra ma anche più avanti. Poi l’iniziativa Radio Robida dell’omonimo collettivo, emittente sulle minoranze curata da ragazzi delle valli del Natisone, a cavallo tra Italia e Slovenia. Anche loro narreranno storie di confine, daranno voce alle specificità marginali linguistiche».
Giustina Selvelli, immaginiamo che fra trenta anni le chiedano di riprendere in mano questo libro e aggiornarlo con eventi che nel frattempo saranno accaduti. Cosa le piacerebbe poter scrivere?
«Mi piacerebbe poter scrivere che vivo in un’unica città in cui non ci si renda conto di quando si sconfina da una parte all’altra; in cui esista perfetto bilinguismo degli abitanti, e non solo, magari si conosca anche qualche altra lingua internazionale; in cui esistano collaudati progetti di incontro, associazioni culturali che operano creando inclusione, dando spazio soprattutto ai giovani; band musicali di confine, formate da membri italiani, sloveni, ma anche, non so, da un bengalese, un nigeriano. Ecco, mi piacerebbe vedere e sentire musica che rappresenti la frontiera aperta, l’ibridazione, il meticciato. E poi un ambiente che rispettiamo di più, un fiume Isonzo più in salute, per il quale si siano trovate delle soluzioni ai danni perpetrati alle sue acque corso dei decenni, il Carso rinverdito dopo gli incendi di due anni fa che hanno determinato la perdita di quasi il 50 per cento della biomassa nel territorio interessato dalle fiamme. E un’unica città sempre più verde: Nova Gorica e Gorizia sono due città molto verdi, però sicuramente si può fare ancora di più. Ecco, questo è ciò che sogno e che vorrei poter aggiungere a una ipotetica nuova edizione arricchita di “Capire il confine” fra trenta anni».

Archivio rubrica “Villaggio solidale”
Aggiornato il 14/06/24 alle ore 05:30