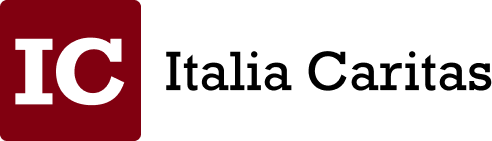La cultura libera. Ascoltiamola!

Daniela de Robert in un momento della registrazione del podcast
Da sempre ci ricorda che il carcere e chi per un periodo più o meno lungo lo abita non è altro da noi. Da sempre è in prima linea per abbattere la separazione tra dentro e fuori. L’impegno di Daniela de Robert per il carcere non si esaurisce, quindi, nel carcere. Consapevole che lo sforzo più grande vada esercitato all’esterno. E lei per 40 anni all’esterno ha portato la voce delle persone ristrette e le loro istanze. Lo ha fatto come giornalista del TG2 e garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Lo fa come volontaria dagli istituti di pena di Rebibbia e nella Direzione Rai per la Sostenibilità – ESG, dove oggi si misura con un mezzo per lei nuovo. Sulla piattaforma RaiPlay Sound trovate il podcast ideato e condotto dalla de Robert “Quando la cultura rompe le sbarre”. Quattro puntate da quindici minuti ciascuna che con la potenza rivelatrice dell’audio ci portano letteralmente dentro un Istituto penitenziario. Dove la cultura è ancora una volta, molto più di altre volte, autentico esercizio di libertà.
:: Ascolta il podcast “Quando la cultura rompe le sbarre”
De Robert, una vita a occuparsi di questioni legate al carcere, a sensibilizzare, partecipare a tavoli istituzionali, raccogliere storie. Quanto è stato difficile selezionare per un podcast di sole – al momento – quattro puntate? E perché quelle testimonianze lì e non altre?
«Perché mi interessava raccontare che in carcere la rieducazione – come indicato dalla Costituzione – non solo è possibile, ma è reale. E quindi ho scelto, anche sulla linea delle attività che stiamo svolgendo con Rai per la Sostenibilità, di sentire alcune persone detenute che sono impegnate nell’attività teatrale nel carcere di Spoleto, che ha una particolarità: gli spettacoli, preparati insieme alla compagnia teatrale, quindi insieme a dei professionisti, sono ormai parte integrante del Festival dei due Mondi. Ciò significa, come ha detto la direttrice artistica Monique Veaute pochi giorni fa, che non è solo l’aspetto sociale a interessare, ma anche la rilevanza artistica».
Lei ha raccontato il carcere e le storie che contiene su quasi tutti i media. Le possibilità che offre trattare questo tema in un prodotto audio. Iniziamo da un particolare, forse ovvio: Il rumore delle porte dell’istituto di pena che si chiudono, qui risuona dentro in modo più potente che, ad esempio, in tv.
«Del carcere io ho sempre cercato di raccontare, essendo una giornalista e sapendo che i racconti sono soprattutto filtrati dalla cronaca, nera o bianca, il tanto grigio che c’è in mezzo. Quindi la verità di una vita privata della libertà. Se il mio libro “Sembrano proprio come noi”, di qualche anno fa, ne accompagnava la quotidianità, il podcast vuole mettere in luce la normalità della privazione della libertà. Quel portone che rimbomba la prima volta ti fa saltare, poi entra nel rumore della vita quotidiana. È il rumore del carcere. Un luogo dove non si è mai in silenzio. Con “Quando la cultura rompe le sbarre” racconto di porte blindate, cancelli, limitazioni, ma soprattutto di come questo contesto così difficile può anche rappresentare una rinascita».

Ha avuto modo di entrare in un istituto di pena per la prima volta a 26 anni. Un aspetto che ruota intorno all’universo carcere rimasto in questi anni pressoché invariato e che lei vorrebbe invece fosse cambiato più di altri.
«Non abbiamo tutti ancora chiaro che il carcere, con la sua privazione della libertà, è un luogo di sofferenza a prescindere dai motivi che ti portano lì dentro. E che la sofferenza difficilmente aiuta le persone a migliorarsi. Vorrei riconoscessimo che quello è un luogo che ci appartiene, che non è altro da noi, che le persone che vivono lì dentro siamo noi quando sbagliamo. In tanti usano l’espressione: buttate la chiave. Queste stesse persone, quando poi vengono toccate in qualche modo dal tema, improvvisamente cambiano sguardo. Qualche giorno fa in un programma su Radiotre una donna che ha scontato la pena, diceva: “Io pensavo che si dovesse buttare la chiave. Oggi so che la realtà è molto diversa”. Riuscire a raccontare quella realtà è anche l’obiettivo del podcast. Quando incontri una persona e non uno stereotipo, un nemico, uno straniero, un detenuto, ma Giovanni, Antonella, Abdul, … allora le cose cambiano».
Eppure nel podcast lo ricordate: a fronte di un sistema penitenziario carente, l’Italia è in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi per quel che riguarda il rapporto con l’esterno. Esistono figure specifiche che si occupano di costruire ponti tra dentro e fuori per realizzare progetti.
«Sì, abbiamo la legge di riforma del 1975 che prevede proprio che la società esterna sia sollecitata dalle direzioni delle carceri a essere parte attiva del processo di rieducazione e risocializzazione dei detenuti. Tutte queste persone che ogni giorno entrano negli istituti di pena per portare conoscenza, specializzazione, attività, cultura, attenzione, ascolto, accompagnamento, costituiscono una ricchezza che va conservata e potenziata. Ma di questi tempi non succede. Si pensa che se meno gente entra, il controllo si esercita meglio. Sono convinta che questo sia un errore e le rivolte, le situazioni difficili che vediamo ce lo confermano: la sicurezza passa attraverso un’attenzione maggiore verso il carcere, non una sua emarginazione. Mentre si consumavano i quasi 60 suicidi dietro le sbarre di questi primi sei mesi dell’anno, sono entrate nel carcere di Spoleto in due serate 1.500 persone a vedere lo spettacolo delle persone detenute. Tutto in un clima di sicurezza, di apertura che è stato costruito nel tempo, ma che è anche frutto di una responsabilizzazione delle persone detenute che partecipano a quella attività e che sanno che non dovranno tradire la fiducia data; anzi, sono responsabilmente attive in questo percorso di accoglienza delle persone dall’esterno».
Ed è ampio lo spazio del podcast riservato al teatro in carcere. Dal 1982, anno del progetto pilota di Rebibbia, a oggi, le esperienze di teatro in carcere si sono moltiplicate. Funzionano soprattutto perché favoriscono l’incontro tra chi è dentro e chi è fuori?
«Funzionano, ma questo vale per il teatro come per tutte le altre occasioni in cui entra l’eccellenza. In un luogo così non puoi portare la mediocrità. E poi funzionano perché il teatro è davvero un gioco magico che ti costringe a entrare nelle vite degli altri. Attraverso questa attività le persone detenute riescono a riflettere sulle proprie vite in maniera meno dolorosa. Il teatro ti permette di specchiarti negli altri, di comprendere te stesso e di fare questo percorso, anche emozionale forte, ma di riflessione, in maniera collettiva. In carcere il tuo corpo è l’unica cosa di cui disponi, ma le persone detenute in realtà rischiano di usarlo solo in modo negativo, impiccandosi, autolesionandosi, facendo lo sciopero della fame e della sete. Be’, quello stesso corpo sul palco riacquista la sua dimensione positiva, la sua ricchezza, l’espressività».

Ci ha ricordato il numero dei suicidi finora. E non dimentichiamo le migliaia di casi di autolesionismo. Queste persone non vedono più un futuro possibile?
«Siccome i due picchi di suicidi li registriamo nei primissimi giorni in cui si entra in carcere – specialmente chi è arrestato per la prima volta – e quando si sta per uscire, la sensazione è che questo grido di disperazione sia rivolto al mondo esterno, non solo all’amministrazione penitenziaria. Come se dicessero: rinuncio alla mia vita perché tanto una volta che entro qui so che non tornerò più a vivere, so di essere finito in un buco nero. L’idea è che quello sia un posto che non interessa più a nessuno. Invece siamo tutti chiamati a lavorare insieme alle persone che hanno commesso dei reati. Pensiamo che delle 61.500 persone attualmente in carcere, quasi 10 mila hanno condanne inferiori ai tre anni. Ecco, queste persone sanno che quando usciranno, lo faranno con tutte le fragilità e le difficoltà di quando sono entrati. Con in più il marchio indelebile dell’essere stati detenuti».
Nel podcast “Quando la cultura rompe le sbarre” parlate di spazio pieno e tempo vuoto. Cosa pesa di più? Se lei, de Robert, potesse eliminarne subito uno, quale sarebbe?
«Il tempo vuoto, perché se fosse pieno vorrebbe dire che le persone escono la mattina da quelle stanze sovraffollate e spesso indecenti e vanno a svolgere attività: teatrali, culturali, lavorative, sportive, … iniziative che hanno e danno loro un senso. Togliere significato al tempo sottraendolo alla vita è una delle cose peggiori che possano esserci. Tempo, tra l’altro, vissuto in condizioni inaccettabili, con le cimici, con letti a castello a tre piani, che significa dover spostare il letto al centro della stanza per aprire una finestra, che non c’è spazio per stare tutti insieme in piedi in quella stanza. Se a certe condizioni aggiungi il tempo vuoto, privato di significato, privato di vita, allora tutto diventa insopportabile».

Perché è così difficile per chi sta fuori capire che alla fine se le persone detenute riempiono questo tempo, rivedono le loro azioni ed escono con una motivazione, è un bene per tutti? Conviene a tutti?
«Perché ci sono degli stereotipi molto forti che vengono continuamente alimentati a causa di una scarsa conoscenza del carcere. Il motivo per cui io voglio raccontare la normalità è perché del carcere non si sa niente. Faccio questo esempio: se noi conoscessimo la scuola solo dagli articoli di giornale che ci parlano del tetto che crolla, dell’insegnante picchiato, penseremmo che quello sia un luogo infernale. Ma siccome tutti i giorni portiamo i nostri figli a scuola, tanti di noi ci lavorano e comunque la scuola è un luogo che conosciamo, sappiamo fare una tara e siamo consapevoli che il tetto che crolla è solo una parte del racconto. Del carcere, invece, noi conosciamo solo quella parte del racconto, gli estremi, la cronaca nera, le cose peggiori. Non conosciamo, ad esempio, la tantissima solidarietà che c’è lì dentro. Quando entra qualcuno che non ha nulla o quando a questo qualcuno accade un fatto particolarmente negativo, immediatamente si attiva una colletta. Ognuno contribuisce come può. C’è anche umanità in carcere. Ma è schiacciata e non ce ne accorgiamo».
Nel 1994 lei ha dato vita all’Associazione VIC – Volontari In Carcere onlus, espressione della Caritas diocesana di Roma. Le cose buone dell’impegno della Chiesa in carcere le sappiamo. Quali, invece, a suo avviso, criticità?
«Credo che il lavoro che debba fare la Chiesa è provare a coinvolgere sempre più la comunità, le parrocchie, la gente comune e farla incontrare attorno a questo tema. A me è capitato diverse volte di andare a parlare nelle parrocchie di carcere e di essere avvicinata alla fine da persone che mi dicevano di avere un figlio, un fratello, un parente detenuto e di non averlo rivelato al parroco perché si vergognano. Il carcere non è solo dentro le mura, è anche le famiglie fuori, che soffrono e che ci riguardano. Non c’è un pianeta carcere: c’è il pianeta Terra, c’è l’Italia con i suoi 190 istituti penitenziari, oggi 189 perché quello di Pozzuoli è stato chiuso per il terremoto. Quando di recente si è verificata in Italia un’alluvione particolarmente disastrosa, molte persone in carcere hanno avuto le famiglie alluvionate. Ci rendiamo conto di cosa vuol dire non ricevere notizie in quei momenti?».
Fondamentale sospendere il giudizio per capire, conoscere. Non per tutti è facile: siamo la somma delle esperienze che abbiamo vissuto.
«Però dobbiamo farlo. Sospendere il giudizio perché queste persone sono già giudicate da chi deve giudicare. Sospendere il giudizio non vuol dire condividere, ma mettersi in ascolto di situazioni diverse dalle nostre. Sono persone che in molti casi non hanno avuto la possibilità di una relazione che non fosse strumentale. Quante volte mi hanno detto: “Daniela, io non pensavo che si potesse stare insieme così senza avere bisogno, senza chiedere, senza usare”. Quindi è un mondo in cui ci sono tutte le criticità del fuori condensate e compresse. E molti sono anziani. Uno degli ultimi detenuti che si è ucciso aveva 83 anni. Contrariamente a quanto si pensi, gli anziani in carcere ci sono e non riescono a uscire perché fuori nessuno li vuole».

Nel podcast troviamo anche le esperienze di carcere e scuola: 20.000 gli studenti detenuti iscritti ai vari corsi. Vi ascoltiamo dire che l’uscita deve essere diversa dall’entrata, altrimenti che senso ha? La scuola è uno degli strumenti fondamentali.
«Senza l’istruzione non hai gli strumenti per comprendere, non solo il mondo attorno a te e gli altri, ma anche te stesso. L’istruzione ti dà modo di riconoscere le fragilità nei tuoi errori, le tue potenzialità, le ricchezze. La scuola dell’obbligo è un presidio presente in tutte le carceri per legge, ma molte persone detenute poi continuano con gli studi superiori o universitari. Sono cose che ti cambiano la vita, che ti aprono il cervello. L’istruzione è uno strumento potente e sarebbe ora che l’amministrazione penitenziaria la smettesse di scrivere in tutti i suoi rapporti “Attività culturali e ricreative”. La cultura non è solo ricreazione, è un’altra cosa».
A tal proposito, il podcast è parte di un progetto Rai che reca quasi lo stesso titolo, “La cultura rompe le sbarre”. Un progetto promosso perché la Rai ritiene che come servizio pubblico deve fare la sua parte in questo processo di reinserimento dei detenuti. Come?
«Una delle cose che abbiamo realizzato riguarda proprio le scuole: i ventimila studenti detenuti erano – che bello poter usare il tempo imperfetto! – gli unici che non avevano accesso alle 1.800 videolezioni di Rai Scuola prodotte per tutti gli studenti in Italia, disponibili online sotto il titolo “La scuola in Tv”. Il motivo è semplice: i detenuti non possono accedere a internet. Allora abbiamo trovato 400 Pc che la Rai stava dismettendo, li abbiamo rigenerati e – come dice il direttore di Rai per la Sostenibilità Roberto Natale – “imbottiti” con le 1.800 videolezioni. Abbiamo fatto realizzare un software ad hoc per rendere navigabile offline il sito e ora stanno arrivando in tutte le carceri d’Italia. È un piccolo segnale. Parlavo qualche giorno fa con la direttrice di Regina Coeli. Sapevo che stavano per arrivare i Pc e cercavo di convincerla dell’utilità del progetto. E lei: “Guarda che non mi devi convincere. Sono anni che gli insegnanti mi chiedono di poter usare le lezioni di Rai Scuola e io gli devo dire di no perché i detenuti non possono usare Intenet!”. L’istruzione è potenziamento. Nel podcast uno degli intervistati, Abdul, dice: “Io quando vado in classe mi sento libero” ».
Mentre, sempre nel podcast, Francesco parla degli incontri che ha tenuto nelle scuole. I ragazzi gli hanno dato la scintilla. E lui ha «iniziato a volersi bene».
«Sì, perché la contaminazione aiuta a crescere e a cambiare. Dobbiamo incontrarci. Il carcere non può essere un luogo chiuso, ostile, nemico, da cui tenersi lontani. Noi abbiamo promosso una gara di cucina con l’Istituto alberghiero di Spoleto nella cucina dell’istituto penitenziario della cittadina umbra. Gli studenti liberi sono entrati per fare questa gara insieme agli studenti detenuti. Erano ragazzi del terzo anno, molto giovani e un po’ agitati. Quando hanno conosciuto le persone detenute si sono trovati subito a loro agio. I pregiudizi si sono sgretolati in una manciata di minuti. È chiaro che si tratta di un’impressione da primo impatto, però hanno lavorato e costruito qualcosa tutti insieme. Una ragazza ha detto in un’intervista che non dimenticherà mai chi le ha confidato: “Con voi non mi sono mai sentito un detenuto e di questo vi ringrazio”. Ecco, l’incontro con le persone abbassa il muro. Poi è chiaro che stiamo parlando di situazioni complesse, ma quello è un mondo che deve tornare a essere parte della nostra società».

Entrando in carcere in tutti questi anni, frequentando le sue storie, i suoi numeri, i suoi cambiamenti, cosa Daniela de Robert ha dovuto imparare a lasciare andare e cosa ha dovuto per forza trattenere?
Ho lasciato andare il giudizio sulle persone. Che non vuol dire non avere un’opinione, ma disporsi in un atteggiamento di ascolto e di condivisione, perché rompere la separazione permette di ascoltare anche ciò che non ci piace. Aprirsi a un mondo dove all’inizio credi soltanto di poter portare qualcosa, ma in realtà poi ti ritrovi profondamente arricchito. Quello che, invece, è stato indispensabile trattenere è il desiderio di incontrare, anche mondi difficili, di non avere paura di un confronto con realtà che possono farmi soffrire. Poi, certo, si impara a prendere le giuste distanze senza per questo diventare estranei, a condividere senza cadere nella buca con loro, ma restando con loro, non dico da pari a pari perché non è così: uno è privato della propria libertà e l’altro no. Però, ripeto, ho trovato fondamentale il mio desiderio di confrontarmi con altri mondi».
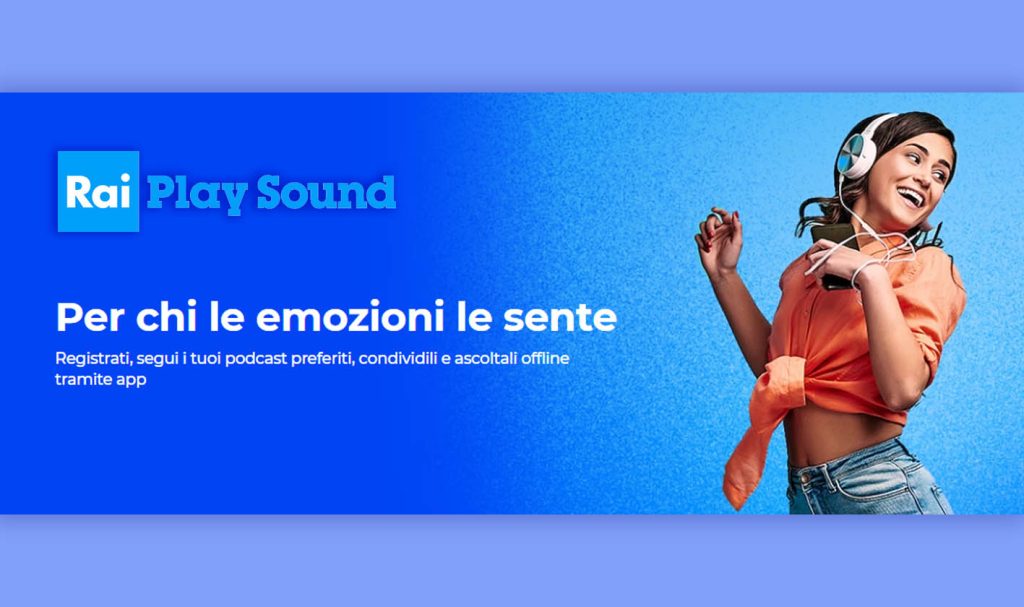
Archivio rubrica “Villaggio solidale”
Aggiornato il 19/07/24 alle ore 09:04