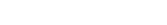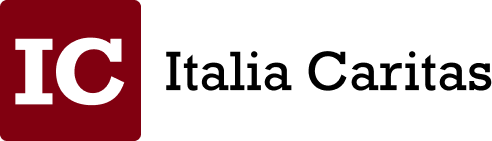La cooperazione allo sviluppo è…

Parafrasando il noto aforisma di Carl von Clausewitz potremmo forse chiederci se la cooperazione possa essere considerata la prosecuzione del mercato con altri mezzi? Sembra essere questa una delle conclusioni dell’interessante webinar sul Piano Mattei organizzato da FOCSIV, Caritas Italiana e Fondazione Missio il 20 febbraio scorso. L’idea che la cooperazione si intrecci con dinamiche di mercato non è nuova, ma oggi assume un significato particolarmente rilevante. È necessario confrontarsi con questo scenario con spirito critico e costruttivo, riconoscendo con lucidità le dinamiche in atto e avviando un percorso di attenzione e discernimento. Lo scriveva don Giovanni Nervo nel 1985, quando parlava della contestatissima legge 73/85 e della necessità di collaborare soprattutto con un’attenta opera di informazione, contribuendo a far crescere una “forma concreta di controllo di base” su come vengono impiegate le risorse pubbliche.
L’intervento del Consigliere Ortona, della struttura di missione del Piano Mattei, che non ha potuto però fermarsi per ascoltare le voci della società civile ed ha affidato a due funzionari il compito di raccogliere eventuali osservazioni, ha ben descritto principi ispiratori e obiettivi del Piano, nonché il mandato della struttura costruita per dare attuazione ad essa. È difficile non rilevare ancora la tensione per certi aspetti irrisolta tra la struttura dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (l’AICS, agenzia messa in piedi solo pochi anni fa, con la legge 125/2014), e la nuova struttura. Una tensione irrisolta che emerge anche dalle parole del Direttore dell’AICS, Marco Rusconi, che ha testimoniato di una presenza da parte dell’AICS in cabina di regia del Piano Mattei, in qualche modo paritetica e senza alcun particolare privilegio di percorso rispetto ai rappresentanti del mondo non governativo. Ciò suggerirebbe difficoltà analoghe anche nel ricevere le informazioni e i documenti, che vengono forniti solo in formato cartaceo e all’ultimo momento, come avviene appunto con le Organizzazioni della società civile. Lo ha ricordato nel corso del seminario Silvia Stilli, presidente dell’Associazione ONG italiane.
Se, tra le due, è la struttura del Piano Mattei ad essere la vera interprete della strategia di cooperazione del nostro Paese espressa con il Piano Mattei, la cooperazione allo sviluppo appare dunque come un “sottoinsieme” di una relazione più ampia, che emerge come sostanzialmente di natura economica. E tuttavia non basta dichiarare i principi di una cooperazione “non predatoria” o di una centralità assoluta della “P” di Persone, se manca la possibilità di una valutazione terza e indipendente, e di una misurazione del peso degli elementi di questa “declaratoria” in termini concreti.
Il dubbio sorge anche in ragione dalle caratteristiche delle iniziative attualmente sostenute con il Piano Mattei, come quella di Bonifiche Ferraresi in Tunisia, rivendicata con orgoglio nonostante i dubbi sollevati in merito dall’arcivescovo di Ferrara mons. Gian Carlo Perego in un recente incontro pubblico: sembra emergere con chiarezza il modello che si persegue, e che prende corpo con la valorizzazione “industriale” di importanti risorse. È lo stesso modello che emerge dal caso del progetto di coltivazione del ricino in Kenya ed affidato ad ENI, che documentato da Report il 17 novembre scorso, dove non sembrano essere i piccoli contadini locali il centro della preoccupazione (la risposta di ENI ai rilievi è disponibile sul sito della RAI). A proposito di “novità nell’approccio”… chi è da qualche anno nel mondo della cooperazione non può fare a meno di ricordare i moltissimi progetti di “contract farming” diffusi in tutta l’Africa Subsahariana negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Sebbene concepiti per incentivare la produzione agricola, molti di questi interventi ebbero come conseguenza principale lo spossessamento di risorse fondamentali per le comunità locali, compromettendo il loro controllo sui mezzi di sussistenza.
Proprio per verificare che non si abbiano effetti collaterali di questa natura sarebbe necessario fare esercizio di trasparenza. È importante l’enfasi sull’Africa, ed è condivisibile l’idea di “sistema Paese” (che ancora una volta in sé non rappresenta una enorme novità). Occorre però chiederci di che tipo di sistema parliamo, dato che al momento sembrano emergere soprattutto partnership con poche grandi e grandissime aziende. Lo stesso si può dire per quanto avviene nel coinvolgimento degli attori del mondo del non governativo: coinvolti finora sostanzialmente “a chiamata” in un numero estremamente ristretto di organismi, e senza che esista un percorso noto e condiviso per accedere alle risorse (pubbliche) mobilitate nel quadro del Piano Mattei. Questo approccio così mirato è possibile – occorre dirlo – anche in ragione del terreno fertile che si trova nel mondo non governativo, con le organizzazioni beneficiarie di tali attenzioni ben felici di sentirsi privilegiate e portatrici di approcci così efficaci da non richiedere alcun particolare confronto. La preoccupazione non è naturalmente quella di partecipare o meno alla gestione di queste risorse (ogni organizzazione pone i propri paletti sulla rispondenza delle proposte del Piano Mattei alla propria mission o al proprio stesso mandato in termini etici), quanto porsi il problema dell’impiego trasparente delle risorse pubbliche, per finalità e secondo modalità che siano soggette a pubblico scrutinio. Come suggeriva don Giovanni Nervo quaranta anni fa.
La necessità di un ampio dibattito e di una corposa riflessione emerge soprattutto quando l’obiettivo è la costruzione di un orizzonte di “bene comune” per un pianeta più sostenibile: un obiettivo che sembra dover trovare un equilibrio con altri, forse oggi considerati più importanti, come l’interesse per i mercati utili alle imprese italiane (quello che in un tempo lontano veniva chiamato “aiuto legato”); controllo e dissuasione della mobilità umana; sicurezza energetica. A meno che tutti questi obiettivi non siano considerati come automaticamente convergenti. Ma così purtroppo non è.
Non è solo il “commercio” (trade not aid) che i Paesi del Sud del mondo chiedono al nostro (come in altre occasioni importanti funzionari hanno rivendicato con una certa durezza), ma anche molto altro, di cui però si fa fatica a trovare traccia nei mandati del Piano Mattei. I governi del “Sud globale” chiedono infatti soprattutto un sistema meno squilibrato e meno ingiusto: se ne parlerà nella Conferenza sulla finanza per lo sviluppo che si terrà a Siviglia nel giugno 2025, e il governo italiano avrà senza dubbio la possibilità di applicare un approccio di cooperazione non predatoria quando verrà posta alla sua attenzione l’opportunità di un trattato sul debito, vero cappio al collo dei Paesi più poveri; e di un trattato globale sulla tassazione, l’assenza del quale rende i Paesi del Sud globale un terreno ideale per qualsiasi gioco di elusione fiscale.
Nel rivendicare una cooperazione diversa, non si tratta dunque di disinteressarsi alle dinamiche economiche, che sono tra l’altro ben rappresentate da ciò che tutto il mondo del non governativo ha posto all’attenzione da molti decenni; ma di comprendere fino in fondo che esse sono parte necessaria ma non sufficiente per un quadro di sviluppo sociale e umano davvero “integrale”, che ponga l’attenzione alla dignità dei più poveri al centro dell’attenzione della solidarietà internazionale. Per questo è necessario che il – fondamentale! – dialogo con i governi dei Paesi del Sud globale sia accompagnato da una valorizzazione dei rapporti sociali e la partecipazione di organizzazioni civiche e organizzazioni di base, dall’apporto delle comunità locali e delle organizzazioni dei produttori. Temi di politica e di partecipazione che cominciavano ad essere centrali quando don Giovanni Nervo scriveva nel 1985, ma che adesso sembrano essere scomparsi dai radar.
Insomma, chiediamo trasparenza alle istituzioni. È necessario però continuare a testimoniare direttamente ed efficacemente una cooperazione basata sulle relazioni e sull’ascolto, su cui costruire un futuro comune di pace.
Aggiornato il 25/02/25 alle ore 08:27