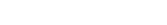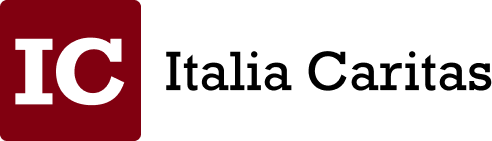Cutro, due anni dopo

Passano le onde sulla spiaggia di Cutro, Calabria ionica, più deboli delle onde che si abbattevano nello stesso luogo la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. La richiesta di soccorso dell’ennesima imbarcazione carica di disperati si disperdeva in un rimpallo di responsabilità tra le diverse autorità che – questo appare chiaro al di là di ogni ragionevole dubbio – avevano precisa cognizione della presenza di questa barca a pochi metri dalla riva, e ogni informazione necessaria a valutare la gravità della situazione.
Le inchieste in corso valuteranno le eventuali responsabilità in quel naufragio, anche se difficilmente emergerà quali fattori abbiano frenato chi forse avrebbe dovuto prendere l’iniziativa, e fare ciò che andava fatto. L’inchiesta lascerà agli atti la ricostruzione della catena degli eventi.
Ma il punto più importante è un altro: ci siamo forse abituati a pensare ogni barca come “l’ennesima barca”, ogni migrante come “l’ennesimo migrante”.
È proprio in questo senso di tragedia ripetuta che si perde nel suo ripetersi la profondità della tragedia di quelle 94 vite spezzate. A cui se ne aggiungono centinaia, migliaia di altre, perdute in naufragi sconosciuti o mangiate dal deserto ancor prima di prendere il mare. L’ennesima tragedia si traduce in un facile meccanismo di neutralizzazione della tragedia, troppe tragedie sono come nessuna tragedia: forse è lo stesso meccanismo di chi ascolta magari ogni notte il ripetersi dello stesso allarme, consapevole di non avere molti strumenti per dare risposte efficaci a un fenomeno la cui ampiezza supera quello di una singola capitaneria di porto, di una regione, di un paese, anche di un continente. Farsi carico dei problemi è compito del governo, l’unica cosa che chiediamo è quella di tenere al centro di ogni scelta la dignità delle persone, senza ignorare l’enorme complessità delle sfide in gioco.
E farlo sapendo che questa attenzione non può limitarsi a una dichiarazione di intenti: colpiscono da questo punto di vista le difficoltà di attuazione della promessa di ricongiungimento dei sopravvissuti con le loro famiglie, su cui il governo si era impegnato all’indomani della tragedia.
Ma è importante anche riaffermare con decisione il principio di solidarietà e di umanità, per cui chi è in difficoltà possa trovare un buon Samaritano disposto ad accompagnare e sostenere, senza essere accusato da chi lo circonda di indurre, con questa sua azione, il proliferare della richiesta di aiuto (meccanismo che nel caso specifico del soccorso in mare come fattore di amplificazione del fenomeno è stato peraltro smentito con chiarezza da autorevoli studi pubblicati a livello internazionale).
Ma sono proprio questi gesti, presenti e diffusi, a fornirci un seme di speranza con cui guardare il futuro di tutti. Segno di contraddizione anche per chi potrebbe e dovrebbe fare, e non fa.
Siamo in un mondo che ci abitua a scelte ‘facili’ e simboliche, dove la dignità delle persone è l’ultima delle preoccupazioni: abbiamo tutti negli occhi le immagini di deportazioni in catene di migranti irregolari. Ma è questo il modo di affrontare queste sfide epocali?
Eppure avremmo tutti gli strumenti per fornire delle risposte efficaci alle necessità delle persone.
Ma questi strumenti, queste possibilità passano in secondo piano, dietro la necessità di un racconto facile e duro che fa breccia nelle stanche opinioni pubbliche dei paesi del ricco “Nord globale”. Siamo noi stessi a dover “restare umani”, compito sempre più difficile e necessario nei tempi che viviamo. Cominciamo dalla memoria di quelle 94 vittime, di cui 34 bambini, e dalla vita delle 80 persone che sopravvissero alla furia del vento.
Aggiornato il 27/02/25 alle ore 08:48