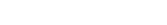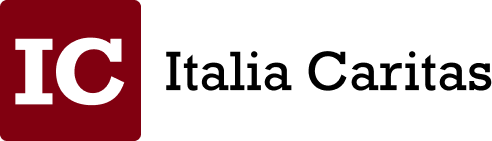La Siria che verrà

La Siria, ferita da oltre un decennio di guerra civile, continua a camminare su un terreno di macerie umane e politiche. La caduta del regime di Bashar al-Assad, era stata salutata dal popolo siriano come la rinascita dell’araba fenice, con un a Siria finalmente risorta dalle ceneri della dittatura alawita durata 54 anni. Poco importa se il vuoto della leadership politica è stato colmato da Ahmed Al-Sharaa; leader di Hayat Tahrir Al-Sham, il cartello di milizie jihadiste nato da una costola di Al-Qaeda che ha guidato il rovesciamento di Assad, il 30 gennaio si è autoproclamato presidente di transizione della Siria e ha promesso di creare un governo ad interim inclusivo, che condurrà il paese fino alla celebrazione di elezioni libere ed eque. Ma gli eventi dello scorso 6 marzo hanno sconfessato le più rosee prospettive democratiche. Tredici soldati delle nuove forze governative sono rimasti uccisi a Jableh, nel governatorato costiero di Latakia, nel corso di un attacco ben pianificato da parte di “residui di milizie fedeli ad Assad”. Latakia non è un territorio a caso, ma è quello che comunemente in Siria viene chiamato “Assadistan”, perché in queste zone si concentra la comunità alawita, principale base di sostegno del vecchio regime. La risposta è stata rapida e brutale: nel giro di tre giorni miliziani riconducibili alle forze governative sono andati casa per casa, uccidendo con esecuzioni sommarie oltre un migliaio di persone, fra militari e civili. Per tentare di rimediare, anche solo parzialmente, alla delegittimazione subita in queste ore, il governo di transizione sta puntando tutto sulle responsabilità individuali di determinati gruppi armati e leader militari, che avrebbero massacrato le comunità alawite di propria iniziativa e, soprattutto, facendo il disinteresse di Damasco. Una responsabilità che è sostenuta anche dalle forze delle SDF curde (Syrian Democratic Forces) che hanno pubblicamente appoggiato la linea delle “responsabilità individuali” tracciata da Damasco, evitando cioè di puntare il dito contro il governo.
A pagare il prezzo più alto, come sempre, sono i civili. All’indomani del 15 marzo, data che segna il triste anniversario di 14 anni di guerra, “l’amata e martoriata Siria” è un Paese dall’umanità distrutta: oltre 600mila morti, famiglie sfollate e affamate, bambini orfani, anziani senza assistenza. A descrivere la situazione è Davide Chiarot, operatore di Caritas Italiana in Siria, dove vive da due anni, nella città di Aleppo.

Che clima si respira ora in Siria? Quale i sentimenti dopo i fatti di venerdì della popolazione? Come è cambiata la visione dell’attuale presidente ad interim Al-Sharaa?
La situazione in Siria è estremamente complessa. C’è grande preoccupazione, soprattutto dopo i massacri avvenuti nei giorni scorsi nella regione costiera, che colpiscono ancor più duramente in un momento sacro come il Ramadan. Sono stati episodi che hanno scioccato trasversalmente gran parte della popolazione. Dall’altro lato, proprio ieri è stato firmato un accordo storico con le forze curde, che lascia intravedere la possibilità di proseguire in questa transizione con la speranza che sia più pacifica e che simili atrocità non si ripetano. Resta però un forte dubbio sulla figura del presidente ad interim, la cui capacità di garantire il controllo della situazione appare sempre più instabile. Ci si chiede se abbia la forza necessaria per indirizzare l’andamento degli eventi e, soprattutto, se gli uomini sul terreno rispondano effettivamente alle direttive della leadership. La preoccupazione era già alta, ma è ulteriormente cresciuta, soprattutto tra le minoranze. Ora è stata istituita una commissione indipendente per indagare su quanto accaduto nel litorale, nella speranza che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Tuttavia, il sentimento comune è quello di un crescente caos e di una totale mancanza di diritto. E questo è lo stato d’animo più diffuso tra la popolazione.
Quale il ruolo dei cristiani e della Chiesa oggi, in questa situazione? È cambiato nel corso degli anni?
Il ruolo dei cristiani in questo momento può essere molto significativo. Da un lato, per la posizione storica che occupano in Siria: una minoranza, sì, ma rispettata e capace di esprimere posizioni chiare. Dall’altro, però, cresce la preoccupazione tra molti di loro, e non poche famiglie stanno valutando l’idea di lasciare il Paese.
La voce della Chiesa non è mai mancata, sebbene a volte permanga una certa ambiguità nei rapporti con il passato regime e nella possibilità, oggi, di avere uno spazio di presenza politica. Tuttavia, alcuni rappresentanti cristiani hanno partecipato ai recenti incontri a Damasco, nell’ambito della conferenza di dialogo nazionale. All’interno della Chiesa ci sono molte esperienze positive di prossimità e dialogo, con uno sguardo rivolto alla pace e alla riconciliazione. Nel loro piccolo, i cristiani possono rappresentare quella presenza capace di abbassare le tensioni e rafforzare il percorso di dialogo nel Paese.
Come Caritas e società civile su cosa è fondamentale investire in questo momento?
L’impegno di Caritas, così come quello della società civile in Siria, da tempo si concentra non solo sull’aiuto umanitario, ma anche sul tema della pace e della riconciliazione, oggi diventato uno dei punti centrali all’ordine del giorno. Come Caritas Italiana, lavoriamo dal 2019 su percorsi di dialogo, pace e trasformazione del conflitto. Un’esperienza pilota è nata proprio a Damasco, attraverso un centro per i giovani, dove cristiani e musulmani trovano uno spazio protetto e accogliente per svolgere attività insieme e costruire percorsi di pace.
Quest’anno abbiamo una grande opportunità grazie a un nuovo progetto chiamato Peacemed, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Questo progetto coinvolge19 Paesi tra la sponda del Mediterraneo, il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Europa meridionale. Prevede un anno di lavoro propedeutico per creare una rete di coordinamento permanente e offrire formazione sui temi del dialogo, della pace, della mediazione e della trasformazione del conflitto.
Accanto alle necessità materiali, la speranza resta un bene essenziale e assolutamente indispensabile.
Aggiornato il 14/03/25 alle ore 06:58