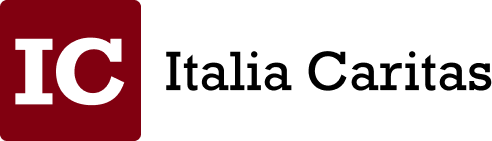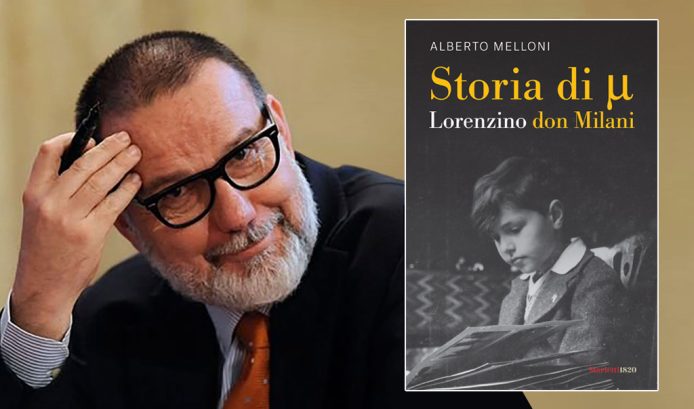Migranti in agricoltura: guarda da vicino

Olmo Parenti durante le riprese
Se avere uno sguardo giovane sulle cose significa anche realizzare un documentario come “One Day One Day”, allora abbiamo un’occasione in più per ribadire che è fondamentale, oltre che giusto e arricchente, ascoltare sempre i giovani. Guardate il documentario: dopo, anche chi ha una consuetudine con le persone immigrate, per amicizia, lavoro, volontariato, guarderà a certe realtà con occhi diversi. Perché Olmo Parenti, il regista e autore del lavoro, ci porta dentro la baraccopoli di Borgo Mezzanone, Puglia, provincia di Foggia, e con la sua cinepresa va vicino, incredibilmente vicino agli ospiti di questa vergogna italiana, braccianti agricoli stagionali provenienti soprattutto dall’Africa, e indugia su espressioni, corpi, parole, suoni che amplificano le possibilità di capire, di sentirli parte di un noi davvero inclusivo.
“One Day One Day” è prodotto dal collettivo One Thing by, di cui Parenti, con i suoi 28 anni, è il membro più “anziano”. Ecco lo sguardo giovane di cui sopra. Un progetto, questo del documentario, sviluppato insieme a Will, media company – oggi acquisita da Chora Media – e community online di più di 1,9 milioni di persone che vuole sensibilizzare sui grandi temi di oggi. «Ci sono già tanti reportage su questo tema realizzati soprattutto da giornalisti televisivi – racconta Parenti –. Sono lavori che osservano queste persone dall’esterno, magari mostrano le loro case mentre non ci sono, riprendono le baraccopoli con un drone da lontano. Noi volevamo fare esattamente l’opposto: guadagnarci la loro fiducia, chiedere il permesso di stare insieme e raccontarli, appunto, da molto vicino».
Ascolta l’intervista integrale a Olmo Parenti
Raccontarli con le loro fatiche, privazioni, la voglia di farcela, la speranza di vivere una vita dignitosa grazie al proprio lavoro, nonostante tutto intorno sia soltanto desolazione.
«Siamo andati in un luogo che la gran parte delle persone non conosce. L’obiettivo non era parlare di caporalato, ma cercare di capire perché questi ragazzi fossero costretti a vivere lì, come funzionasse il nostro sistema di accoglienza – spoiler: non funziona! –, capire chi fossero questi braccianti agricoli, come fossero rimasti intrappolati in quel posto e documentare il loro tentativo di uscire dalla baraccopoli».
Già Il titolo, “One Day One Day”, ci dice di questa speranza.
«È una sorta di mantra che tanti dei ragazzi di queste baraccopoli si ripetono quando gli parli di futuro, dei loro piani. Molto spesso ti diranno che, certo, oggi si trovano in questa condizione, però, insomma, “un giorno un giorno” riusciranno a uscirne e la loro vita cambierà. Nel caso specifico di questi ragazzi, perdere la speranza vuol dire lasciarsi morire. Credo ci sia molto da imparare da loro: riescono a mantenere una positività per noi impensabile in una situazione del genere. Ma il titolo del documentario vale anche un po’ per noi italiani, perché sembra la risposta che ci diamo davanti a molti problemi a cui dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni ma su cui tendiamo generalmente a procrastinare».
Vedi il trailer di “One Day One Day”
Cosa sapevate della realtà della baraccopoli di Borgo Mezzanone prima di girare?
«Sapevamo cos’era prima di diventare quello che è oggi: una pista di atterraggio dell’aeronautica militare abbandonata a metà degli anni ’90. Sapevamo che ci vivono circa quattromila giovani migranti tra senegalesi, ghanesi, nigeriani. Tutte informazioni che arrivano dagli articoli di giornali, i servizi televisivi su questo tema. Noi non siamo giornalisti, siamo filmmaker e il nostro è, ripeto, uno sguardo dall’interno sulla vita di queste persone».

Siete rimasti con questi ragazzi circa un anno. Una sorta di osservazione partecipante? Un po’ filmmaker e un po’ antropologi?
«Non lo so. Sicuramente persone. Noi pensavamo di rimanere a Borgo Mezzanone una settimana per fare un breve reportage; ma siamo diventati subito amici delle persone che vivono lì dentro, perché sono ragazzi della nostra età. Nata l’amicizia, è diventato complesso andare via senza raccontare la loro storia come si deve. Quindi siamo rimasti tanto tempo, fino a quando ci siamo resi conto di avere in mano un racconto onesto su quello che succede laggiù».
Crediamo che per chi vede “One Day One Day”, quando poi si trova a incrociare gli sguardi di queste persone, per strada, su un autobus, … qualcosa cambia. La cinepresa di Olmo Parenti scruta fino in fondo e ci rende consapevoli.
«Questo è il più bel complimento che potessimo ricevere! Sapere che in chi assiste al documentario avviene un cambiamento nel modo in cui dopo la visione guarda determinate persone è la cosa che mi fa più piacere. Molto banalmente cerco di mettermi alla pari, di non sentire pietà per le persone ma provare a capire da dove arrivano e come è la loro vita. Instauro un rapporto, che non è volto alla creazione di un prodotto o a ottenere qualcosa nell’immediato, ma è semplicemente voglia genuina di conoscere gli altri».
«Sapere che in chi assiste al documentario avviene un cambiamento nel modo in cui dopo la visione guarda determinate persone è la cosa che mi fa più piacere»
Con uno dei ragazzi intervistati, tra l’altro fuggito da un Paese in guerra, parlate anche di sentimenti, della possibilità di trovare una compagna. Lui le dice: “Non che io mi blocchi, proprio non provo sentimenti. Come potrei stando qui?”
«La storia a cui si riferisce è quella di Aboubakar (foto sotto), che da sei anni vive in una macchina senza il motore. C’è soltanto la carrozzeria di quest’auto che lui ha trasformato nella sua casa. Aboubakar sostiene che non può pensare di condividere la sua vita con una donna, innamorarsi di qualcuno, senza un posto dove manifestare questo amore, dove stare insieme. Dice anche: “Immaginati se facciamo dei figli. Dove li mettiamo? Qui in macchina?”. Fa un discorso molto pragmatico, che ha un effetto preciso sulle emozioni che può permettersi di vivere. Questa testimonianza arriva in modo molto forte alle persone che guardano il documentario».
Sempre Aboubakar su sua domanda, Parenti, di cui sentiamo la voce fuori campo, ammette di non raccontare ai familiari a casa, in Africa, la situazione che vive per non dare loro altri pensieri. Aggiunge: “Se sei uomo devi ingoiare la saliva, non sputarla fuori”. Ecco la dignità di queste persone, l’attenzione verso i propri cari lontani, che il documentario pone in evidenza…
«Sanno di essere soli al mondo. Sono persone che nel nostro Paese praticamente non hanno diritti e che molto spesso si ritrovano a dover cercare di uscire da una situazione terribile da soli. Non possono neanche fare affidamento sulla propria famiglia, che molto spesso vive difficoltà ancora più grandi e dunque “vomitarsi” addosso reciprocamente il racconto di situazioni così difficili non può aiutare. L’arma che hanno a disposizione è sempre quella: la speranza, che non perdono mai. Anzi, Aboubakar alla fine dichiara: “Se agli italiani va bene, rimango con loro per sempre”. Perché l’Italia è l’unico posto al mondo in cui lui voglia vivere. Credo che una cosa del genere sia quasi incomprensibile dal nostro punto di vista. Forse perché non abbiamo mai provato la gratitudine che sentono loro nel momento in cui vengono soccorsi in mare».


Un altro dei ragazzi parla di alcuni gesti di disprezzo subiti in prima persona da parte di italiani. E si chiede: “Ma non sono un essere umano? Io non lo farei mai a te… Se non ci si capisce a vicenda come può esserci amore?”. Da quello che lei ha visto è così difficile per molti anche in questo caso provare compassione, nel senso vero, alto della parola?
«Ci interessa più chi sta meglio di noi che chi sta peggio. Siamo più concentrati a migliorare la nostra condizione che non ad aiutare chi vive in grandi difficoltà. Io lo trovo paradossale, soprattutto in un momento storico come questo, perché è molto più complesso migliorare la propria vita, “diventare più ricchi”, appartenere a uno status più alto, che non cadere e finire in disgrazia; quindi forse dovremmo prestare più attenzione a chi sta peggio di noi e cercare di dargli una mano sperando che semmai dovesse succedere a noi anche loro facciano lo stesso».
C’è qualche rapporto di amicizia instaurato con questi ragazzi conosciuti a Borgo Mezzanone che continua a più di un anno dalla fine delle riprese?
«Con quasi tutti. Purtroppo le loro storie, a distanza di oltre un anno dalla fine delle riprese, continuano a non essere semplici. Il ragazzo di cui parlava, quello che si domanda se è davvero un essere umano, è morto un mese fa in un incidente stradale, o meglio, è stato investito mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta sulla Statale 16 a San Severo. Tutti gli altri protagonisti del film li sentiamo quasi quotidianamente. Di più, uno di loro – forse non lo dovrei dire perché nel nostro Paese non è legale aiutare una persona in questo modo, ma lo dirò lo stesso – vive attualmente nel nostro studio a Milano. Stava provando ad andare in Germania ma è stato bloccato dalle autorità. Non avendo un posto dove stare abbiamo deciso di ospitarlo».
«Le loro storie, a distanza di oltre un anno dalla fine delle riprese, continuano a non essere semplici. Il ragazzo che si domanda se è davvero un essere umano è morto un mese fa, investito mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta. Tutti gli altri li sentiamo quasi quotidianamente»
Si parlava di far diventare la baraccopoli di Borgo Mezzanone una cittadella dell’accoglienza, di un progetto di 3 milioni e mezzo di euro. A che punto siamo?
«Non saprei di preciso. L’ultima volta che sono stato lì non ho visto alcun tipo di progresso. Mi sembra sempre tutto uguale. Non credo, però, che migliorare la baraccopoli sia una soluzione. Non si può pensare di integrare delle persone senza includerle. Creare una cittadella dell’accoglienza in mezzo al nulla e non in mezzo alla vita degli italiani è per forza di cose una strategia fallimentare, perché queste persone continueranno a essere ghettizzate. Puoi anche spenderci venti milioni di euro, ma se loro non entrano in contatto con noi e non sono inclusi nel nostro quotidiano non impareremo mai a capirci».
E intanto – credo lo abbiate visto anche voi mentre eravate lì – l’associazionismo, le organizzazioni ecclesiali assicurano una presenza, laddove lo Stato latita…
«Assolutamente. Organizzazioni come la Caritas fanno un grande lavoro sul territorio, però spesso sono delle pezze alle mancanze di queste persone. Da un certo punto di vista sono anche delle pezze che fanno comodo a tutti perché la vita di questi ragazzi rasenta il vivibile. Noi mettiamo a loro disposizione il minimo necessario per sopravvivere in maniera tale da non dover trovare una soluzione, un’alternativa a quel posto. Nel momento in cui l’acqua potabile o quel poco di elettricità che arriva nella baraccopoli o i pasti che la Caritas riesce a dare loro dovessero mancare, ecco, questa realtà diventerebbe una bomba a orologeria».

«Non si può pensare di integrare delle persone senza includerle. Creare una cittadella dell’accoglienza in mezzo al nulla e non in mezzo alla vita degli italiani è per forza di cose una strategia fallimentare»

Da settembre 2021 il documentario è pronto. Tante le porte in faccia ricevute all’inizio quando lo proponevate. Il tema immigrazione è in testa a tante agende politiche e poi un prodotto del genere non interessa?
«È un tema polarizzante che pensiamo di conoscere molto bene visto che ne parliamo da anni, ma poi è molto facile voltare lo sguardo altrove, perché ormai quasi ci annoia. Il tema immigrazione lo abbiamo visto trattato in mille modi tra telegiornali, documentari, film, per cui capisco se le persone non ne vogliono sapere. Temo però che questo sia soltanto l’inizio di un fenomeno che caratterizzerà tutte le nostre vite. Il mondo non è un posto migliore rispetto a prima, anzi, sta diventando sempre meno vivibile. Stiamo per assistere a flussi migratori come mai finora. Ci sono tantissimi Paesi in cui le persone non potranno più vivere e dovranno spostarsi. Quindi se pensiamo che questa cosa ci abbia stancato, forse dobbiamo ripensare il nostro punto di vista e cercare di informarci per capire come far fronte alle prossime crisi».
I primi a mostrarsi interessati al documentario sono stati quelli di Will Media. E con la loro partnership avete iniziato a presentare “One Day One Day” nelle scuole un po’ in tutta Italia.
«Le scuole hanno dimostrato di aver fame di cose fatte appositamente per loro. Quando abbiamo lanciato questo documentario sui social, non abbiamo neanche specificato di cosa parlasse, soltanto che era un argomento che ci riguardava tutti, ma che nessuno in realtà voleva vedere e che lo avevamo realizzato per chi ancora non ha imparato a distogliere lo sguardo, dunque i ragazzi, chi ancora non è diventato adulto. Soltanto dicendo questo nel giro di pochi giorni ci sono arrivate 500 richieste da scuole di tutta Italia che poi noi abbiamo cercato di soddisfare, anche partecipando alle presentazioni, sia in presenza che attraverso delle dirette Zoom. Gli studenti sono rimasti molto colpiti dal documentario. E loro, a differenza degli adulti, ti chiedono subito cosa possono fare, cercano di pensare a una soluzione al problema».
«Gli studenti delle scuole in cui abbiamo presentato “One Day One Day” sono rimasti molto colpiti. E loro, a differenza degli adulti, ti chiedono subito cosa possono fare, cercano di pensare a una soluzione al problema»
Con le scuole è partito il tam tam, che ha suscitato l’interesse anche da parte di alcuni esercenti cinematografici. Il documentario si può dunque vedere al cinema?
«Sì, è in giro nei cinema ormai dal maggio scorso. Abbiamo deciso di fare una distribuzione dal basso, indipendente, iniziando da una decina di cinema. E poi dicendo alla community che ci segue sui social di proporre il documentario alle sale cinematografiche dei rispettivi quartieri e che saremmo poi andati a presentare il lavoro in tutti i cinema che ce lo avessero chiesto. È dunque una modalità distributiva diversa dal solito, che vuole far diventare ogni proiezione un piccolo evento, in cui ci si incontra e si discute su quello che si è visto. Informazioni su willmedia.it».
Ci si augura sempre che la platea sia ampia, anche e soprattutto per temi del genere, più complessi di quello che sembrano. Olmo Parenti, lei spesso ha a che fare anche con riscontri monstre, numeri altissimi per prodotti ultrapop. Leggo su YouTube un numero che si avvicina a 50 milioni. Sono le visualizzazioni ad oggi del videoclip dell’estate, quello che accompagna il tormentone “La dolce vita” di Fedez e compagnia, realizzato proprio da lei. Abbiamo mischiato due cose diversissime tra loro, ma come si fa con un documentario a sensibilizzare e arrivare a più persone possibili? Certo non a 50 milioni… Glielo chiediamo anche per chi nelle varie Caritas si occupa di comunicazione.
«Trovando un’idea per lanciarlo e per guadagnarsi l’attenzione delle persone. Noi lo abbiamo fatto con un claim che aveva una sua forza: “Non volete vedere il nostro documentario perché l’immigrazione vi ha rotto le scatole? Benissimo, non ve lo faremo vedere! Lo proietteremo soltanto nelle scuole e sarà il primo film della storia vietato ai maggiori“. Questo ha fatto sorridere un sacco di persone ma ha anche risvegliato la loro attenzione. Certo, il nostro documentario non lo hanno visto 50 milioni di persone, ma magari lo hanno visto in 10 mila, non da soli nelle rispettive abitazioni ma insieme nelle scuole e nei cinema, e sono convinto che queste 10 mila persone sono tornate a casa pensando a quello cui avevano appena assistito. Poi ci deve, certo, essere spazio anche per ciò che è pop, ma i videoclip dei tormentoni estivi verranno realizzati a prescindere dalla nostra esistenza e dal nostro impegno. Per cui ci siamo detti che è indispensabile realizzare cose fatte di buone idee e buoni valori».


Lo scrittore americano John Steinbeck dava alle stampe nel 1937 il romanzo “Uomini e topi”. I due protagonisti sono braccianti stagionali. Olmo Parenti, se oggi Steinbeck fosse qui e andasse a Borgo Mezzanone, scriverebbe ancora di uomini e topi?
«Io credo di sì. È purtroppo una dinamica senza tempo. Sarebbe bello trovare un lieto fine a questa storia e riuscire a raggiungere un’uguaglianza o almeno una tensione all’uguaglianza. Non mi sembra che stiamo andando in quella direzione, ma arrendersi non serve a niente e quindi di certe cose continueremo a scrivere, a fare documentari, a parlare, nella speranza che prima o poi qualcosa cambi» (fine).
«Di certe cose continueremo a scrivere, a fare documentari, a parlare, nella speranza che prima o poi qualcosa cambi»